
Riccardo Cucciolla, Giuliano Montaldo e Gian Maria Volonté sul set di “Sacco e Vanzetti”. Regia: Giuliano Montaldo. Produzione: Arrigo Colombo, Giorgio Papi (Italia, Francia 1971) (di Cucciolla e Volonté la rubrica si è occupata nell’articolo del 24 novembre 2022: link)
Negli anni Ottanta del Novecento, dopo la fase più sanguinosa degli anni di piombo, il giurista tedesco Günther Jakobs teorizza la necessità di una differenziazione del diritto penale coniando la definizione di “diritto penale del nemico”. Jakobs intende dare uno statuto preciso a un binario che nel diritto sta diventando autonomo.
Il “diritto penale del nemico” non indaga il cittadino come individuo comune ma il cittadino come nemico pubblico sulla base di azioni o anche di dichiarazioni teoriche. Tale principio normativo seleziona i presunti criminali con principi soggettivi ed entra in conflitto, a volte, con il rispetto dei diritti umani, soprattutto se si applicano particolari misure detentive. Secondo il “diritto penale del nemico”, in una determinata congiuntura lo Stato individua il nemico pubblico all’interno di gruppi o consorzi sociali, con uno stravolgimento della predominanza della tutela giuridica del cittadino quando lo Stato ritiene che la propria stabilità sia in pericolo.
Un esempio di embrionale “diritto penale del nemico”, che colpisce gruppi considerati socialmente pericolosi condannando duramente alcuni rappresentanti di essi, sta, a ben guardare, già nel processo americano a Nicola Sacco e a Bartolomeo Vanzetti.
I due immigrati dalle province di Foggia e di Cuneo furono giustiziati sulla sedia elettrica il 23 agosto 1927 nel penitenziario di Charlestown, nei pressi di Boston. Il processo penale in cui furono imputati Sacco e Vanzetti fu il primo processo politico della storia contemporanea del quale siano stati vittime italiani giudicati per la provenienza, il grado di istruzione, la condizione sociale e l’attivismo politico. Difatti Sacco (operaio in una fabbrica di scarpe) e Vanzetti (venditore ambulante di pesce) erano immigrati, anarchici, poveri e parlavano male l’angloamericano: per queste ragioni furono accusati ingiustamente e condannati per un duplice omicidio che non avevano commesso e di cui si conoscevano i responsabili.
La punizione immeritata non seguì alla lesione del diritto ma fu strumentale alla repressione preventiva di tipologie di cittadini reputate dallo Stato pericolose socialmente. Ai tempi di Sacco e Vanzetti in America, oggi in Italia, gli immigrati, i poveri, gli anarchici e chi non adegua la propria vita familiare e privata alle idee di chi governa sono considerati un pericolo e pertanto si adottano contro di loro misure di respingimento o di riduzione dei diritti che appaiano esemplari e facciano da deterrente.

Riccardo Cucciolla e Giuliano Montaldo sul set di “Sacco e Vanzetti”. Regia: Giuliano Montaldo. Produzione: Arrigo Colombo, Giorgio Papi (Italia, Francia 1971)
Uno dei più grandi attori della storia del cinema internazionale ha reso immortale la fierezza di Vanzetti nel film che fu decisivo per la riabilitazione dei due anarchici, “Sacco e Vanzetti” diretto nel 1971 da Giuliano Montaldo, morto il 6 settembre scorso. Nel film di Montaldo, Vanzetti affronta il boia e il pubblico che assiste alla sua esecuzione trasformando la sua condanna capitale in un atto di resistenza politica: “Viva l’anarchia” pronuncia Vanzetti, a voce bassa, con il corpo e la voce di Gian Maria Volonté. Dopo che Volonté/Vanzetti viene legato alla sedia elettrica e dichiarato morto, il film si chiude con la dedica sui titoli di coda, che non è una frase in esergo come di consueto ma la ballata “Here’s to you” di Ennio Morricone cantata da una delle artiste politiche per eccellenza, Joan Baez.
Il valore civile di “Sacco e Vanzetti” fu avvalorato dai legami strettissimi con la storia contemporanea: nel 1971 l’Italia è dilaniata dalle reazioni alla strage di piazza Fontana. In seguito all’attentato del 12 dicembre 1969 alla Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano si batte come al solito la pista anarchica, perseguitando un editore milionario, alcuni dei suoi familiari (per questa vicenda si può partire dal bel libro di Carlo Feltrinelli, Senior service, del quale la rubrica si è occupata nell’articolo dell’11 marzo 2022: link), un ballerino anarchico e un ferroviere anarchico.
Il ferroviere, Giuseppe Pinelli, tra il 15 e il 16 dicembre 1969 muore precipitando da una finestra della Questura di Milano dopo che è stato trattenuto più delle quarantotto ore previste dal fermo di polizia. Nel film di Montaldo si ripete spesso la scena in cui un anarchico amico dei due imputati, il tipografo Andrea Salsedo, precipita dalla finestra del Bureau of Investigation di New York dove era trattenuto illegalmente da tempo.
L’incarnazione di Vanzetti in Volonté non fu la sola interpretazione che l’artista unì agli altri suoi meriti di cittadino attivo per i diritti civili e politici dei più deboli, vivendo profondamente le sue scelte professionali in chiave di dichiarazioni politiche. Il motto che accompagnò anche i momenti più privati dell’esistenza di Volonté (tanto da essere scelto dalla compagna Angelica Ippolito e dalla figlia Giovanna Gravina come epitaffio per la sua tomba) era un verso da “Le Cimetière marin” di Paul Valéry: “Le vent se leve, il faut tenter de vivre” (“Si alza il vento, bisogna provare a vivere”). Il verso stava sulla barca che Volonté usò non solo per diporto: nel 1981 trasportò in Corsica Oreste Scalzone, il leader di Autonomia Operaia, perché poi potesse riparare in Francia e sfuggire alle ricadute (pesantissime anche in termini di salute fisica) del processo penale rientrante nell’inchiesta del “7 aprile”.
“7 aprile” è l’etichetta con la quale è nota un’ampia inchiesta giudiziaria culminata in una serie di catture il 7 aprile 1979 per iniziativa del magistrato Pietro Calogero, attivo a Padova e già noto per avere indirizzato correttamente sulla pista “nera” neofascista le indagini per la strage di piazza Fontana (p. XIII). Dal “7 aprile” scaturirono i processi politici che interessarono gli autonomisti operaisti in Italia dal 1979 e che segnarono l’orientamento della giustizia politica dopo l’omicidio di Aldo Moro.
Nell’inchiesta e nei processi “7 aprile” furono infatti progressivamente trascinati numerosi esponenti della sinistra extraparlamentare operaista italiana, a cominciare da professori e funzionari universitari e intellettuali di vario rango che furono giudicati come teorici e, almeno per una lunga fase, capi o esponenti di spicco o fiancheggiatori delle Brigate Rosse: Toni Negri in primo luogo, insieme a Franco Piperno, Enrico Fenzi, Franco Gavazzeni, Caterina Pilenga in Consolo, Mauro Borromeo.
Del ruolo di cesura storica rappresentato dai processi “7 aprile” nella fase successiva alla morte di Moro ha scritto con equilibrio di storico formatosi, come me, alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Roberto Colozza (oggi ricercatore all’Università della Tuscia) nel libro “L’affaire 7 aprile. Un caso giudiziario tra anni di piombo e terrorismo globale” (Einaudi 2023).

“L’affaire 7 aprile” è complessivamente ben scritto e riesce anche a essere lievemente ironico nei momenti giusti della storia; qualche volta la lingua, asciutta e referenziale, indulge nell’uso di espressioni generiche dell’oralità e del giornalismo contemporanei come “narrazione” (oggi “nuova narrazione” si usa per indicare un “racconto di fatti diverso da quello tradizionale”), pur se quasi in tutto il libro Colozza cerca opportunamente una lingua aderente il più possibile alla materia e alla cronologia trattate.
La ricostruzione del quadro del clima successivo alla morte di Moro è una delle risposte offerte dal libro di Colozza. Il clima post Moro era incandescente anche perché stava a breve distanza da due date decisive: “le prime elezioni dirette del Parlamento europeo” e le “prime elezioni legislative dopo la morte di Moro” (del resto, Colozza ricorda giustamente che il “giorno in cui Moro cadeva nelle mani dei brigatisti, il Pci votò la fiducia al quarto governo Andreotti e ostentò lealismo in nome del supremo interesse nazionale”: p. 35). Per i legami, veri o presunti, tra alcuni degli imputati e la vicenda del sequestro Moro, dunque, una parte dell’inchiesta fu presto di competenza di Roma (pp. XI, XIII).
L’autore precisa che al volume ha dedicato una “lettura attentissima” (p. XXI) Miguel Gotor (professore associato all’Università di Roma “Tor Vergata”), che ha studiato le carte scritte da Aldo Moro durante la prigionia (il lavoro di Gotor è confluito nei libri Aldo Moro. Lettere dalla prigionia, Einaudi 2008, e Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del potere italiano, Einaudi 2011, che insieme alle ricerche di altri storici come Francesco Maria Biscione sono alla base della drammaturgia pubblicata nel libro Con il vostro irridente silenzio. Le lettere e il Memoriale: voci dalla prigionia di Aldo Moro, Feltrinelli 2022, che Fabrizio Gifuni porterà nuovamente in scena il prossimo inverno nel suo spettacolo Con il vostro irridente silenzio: link).
Con il “7 aprile” si modifica lo statuto del processo penale per reati politici in Italia. Il processo penale specificamente politico coinvolge cittadini italiani perseguiti sulla base di reati d’opinione o di fatti di sangue intesi dalla magistratura come diretti ad attentare alla stabilità dello Stato. Lo Stato di diritto in questa occasione adotta progressivamente misure eccezionali di marca antiterroristica, non ritenendole una corruzione dello Stato di diritto bensì un adattamento legittimo ai presunti reati di cittadini che hanno lanciato una sfida per colpire al cuore lo Stato stesso; poiché questi cittadini non rispettano le norme fondamentali del vivere civile, lo Stato si sente autorizzato a combattere i cittadini che con parole, metodi e logiche bellici ne contestano i poteri (p. XIII).
Non casualmente accuse “iniziali assai gravi si rivelarono presto infondate” e la chiusura dei vari processi ridimensionò l’iniziale portata del quadro accusatorio sia per i reati associativi (associazione sovversiva, banda armata, insurrezione armata) sia per vari reati specifici (p. XII). Per criminalizzare un’intera generazione politica si adottano metodi e contenuti d’inchiesta estremi: “imputazioni troppo pesanti, durata del carcere preventivo, prove basate spesso su scritti degli imputati. Un ‘processo di connivenza’” (cioè un processo rispettoso delle regole del gioco processuale, distinto dal “processo di rottura”, pensato per boicottarle: su questo nodo Colozza, pp. XII, 294 n. 3, rinvia al classico libro di Jacques M. Vergès, “Strategia del processo politico”, Einaudi 1969).
Il libro inizia a Padova nel maggio 1975 con i disordini provocati dai gruppi della sinistra extraparlamentare per impedire un comizio del “presidente della formazione neofascista Movimento sociale italiano – Destra nazionale”, il monarchico Alfredo Covelli. Si intreccia ai fatti che, sulla base della tardiva chiamata in correità del pentito già in Lotta continua Leonardo Marino, portano alla condanna di Ovidio Bompressi come esecutore materiale e di Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani come mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi in seguito al volo dell’anarchico Pinelli dalla finestra dell’ufficio di lui (sull’impianto inquisitorio che in questo processo scivolò “verso l’inquisitoriale”, Colozza alle pp. 280, 347 n. 189 rinvia al libro che Carlo Ginzburg scrisse tra 1990 e 1991 per influire sull’esito del processo d’appello al fine di smontare le presunte prove addotte contro Sofri, poi condannato in via definitiva, deprecando il giudice ridotto a storico che “inquina irrimediabilmente l’esercizio della giustizia”: “Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri”, Einaudi 1991, ristampato nel 2020 da Quodlibet, è anche una guida per la ricerca di Colozza, come si deduce da p. XIV, 296 n. 13).

Il libro “L’affaire 7 aprile” si chiude nel gennaio 2007 con la fine della latitanza di Oreste Scalzone, che può rientrare in Italia grazie alla prescrizione dei reati (pp. 3, 294) e che adesso è impegnato su un set cinematografico per interpretare una figura molto simile a quella che fu la sua.

Oreste Scalzone a Napoli sul set del film “Rosso pompeiano”, diretto da Prescilla Martin, con Iaia Forte, in lavorazione
Il titolo del libro di Colozza fa riferimento a due casi giudiziari nei quali è stata fondamentale l’opinione pubblica impegnata e divisa attorno a essi.
Uno è l’affaire Dreyfus (al quale Roman Polanski ha dedicato il film “J’accuse”, in italiano diffuso col titolo “L’ufficiale e la spia”), dopo il quale il termine “affaire”, praticamente intraducibile, ha caratterizzato un rovesciamento di ruoli tra accusatore e accusato. All’affaire Dreyfus lo scrittore Anatole France paragonò non a caso il processo a Sacco e a Vanzetti, difendendo le ragioni dei condannati a morte sulle pagine di “Nation”. In un affaire l’accusato subisce inizialmente il castigo o la relativa minaccia, ma reagisce denunciando chi l’accusa e costruendo una strategia di contrattacco per convincere la società delle proprie ragioni” (p. XII). L’altro caso è il vero e proprio oggetto della ricerca, ricondotto dallo studioso allo statuto di affaire contemporaneo.
Il sostituto procuratore Calogero ebbe l’intuizione di “indagare i teorici della sovversione attraverso i loro scritti”. L’intuizione fu, per i detrattori, il vero punto debole del metodo d’inchiesta, perché fondato su un “procedere deduttivo, in cui le parole erano trattate come reati in sé, scollegate da fatti e circostanze” (p. 37). In questo modo si inverte l’onere della prova: spetta agli imputati dimostrare la propria innocenza e le parole sono pari a reati, così come al centro dell’analisi giudiziaria stanno “la personalità dell’imputato, il suo modo di essere” (pp. 129). Il giudice Calogero inaugurò un metodo di indagine che alcuni osservatori non trovarono inedito, dato che lo Stato resuscitò e adattò alla contemporaneità manovre da “soave inquisizione”: così ne scrisse il penalista Tullio Padovani; del precedente dell’Inquisizione come metodo di indagine nel “7 aprile” parlò pure Luigi Ferrajoli, teorico del garantismo penale (pp. 85 e 138). Non fu un espediente retorico dotto chiamare in causa l’Inquisizione, dato che il tribunale per gli eretici era diventato effettivamente tra Cinquecento e Seicento un tribunale censorio della moralità quotidiana dei cittadini attraverso l’uso poliziesco dello strumento della confessione, piegato a vari scopi (lo ha spiegato Adriano Prosperi nel libro di riferimento sul tema, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi 1996).
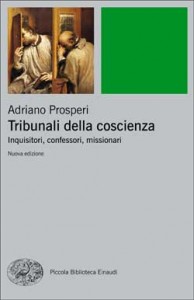
Le imputazioni del “7 aprile” avevano lo scopo di cominciare a dare una struttura alla lotta tra Stato e gruppi della lotta armata, smantellando questi ultimi. L’omicidio di Aldo Moro permetteva infatti a tesi come quelle di Calogero di acquistare una “spendibilità politica di portata nazionale” (pp. 17-18). Non casualmente il principale imputato del “7 aprile”, Toni Negri, l’enfatico professore ordinario di Dottrina dello Stato all’Università di Padova, si aggiungeva agli accusati per la strage di via Fani e per i fatti a essa seguiti (pp. 23-24), con l’accusa di essere il capo delle Brigate rosse e di avere perciò attentato all’integrità della Repubblica.
La testa del professor Negri era stata richiesta direttamente da Roma: l’ordine di cattura emesso da Calogero a Padova il 7 aprile 1979 colpiva Negri dopo che due giorni prima il procuratore Guido Guasco, che a Roma indagava sul caso Moro, aveva avanzato l’istanza di emettere un mandato di cattura per Negri ritenuto implicato nei fatti di via Fani al fine di “suscitare la guerra civile”. Eppure i rapporti tra il professore e le BR avevano “raggiunto la divaricazione massima” proprio durante i giorni del rapimento di Moro (p. 32).
Da Padova a Negri e ad altre undici persone venivano contestati reati gravissimi: banda armata in relazione ai crimini di attentato contro la Costituzione dello Stato, insurrezione armata contro i poteri dello Stato per avere organizzato e diretto le Brigate rosse, associazione sovversiva per avere organizzato e diretto Potere Operaio e altre organizzazioni collegate riferibili ad Autonomia Operaia. Tutti questi reati figuravano nella normativa del codice penale, “d’età fascista e tuttora vigente” (cito da p. 23), detto “codice Rocco” dal cognome del giurista Arturo (fratello del guardasigilli Alfredo) che durante il Ventennio ne era stato principale estensore.
In occasione del “7 aprile” il codice Rocco venne in soccorso della magistratura anche per incoraggiare gli imputati al ravvedimento. Gli artt. 62, 308, 309, 311 del codice, infatti, prevedevano attenuanti, fino alla non punibilità in alcuni casi di cospirazione e banda armata. A questi ambiti si erano aggiunti quelli del sequestro a scopo di estorsione e quello a scopo terroristico, “promosso a reato specifico qualche giorno dopo il rapimento Moro”. Infine, con la “legge Cossiga” della fine del 1979 nasceva il cosiddetto “pentito”. La norma prevedeva “l’impunità di un ‘colpevole’ che avesse consentito il raggiungimento di concreti risultati: impedire un reato, consentirne la ricostruzione fattuale e permettere la cattura dei complici fornendo ‘elementi di prova determinanti’” (pp. 83-85, 314 nota 12).
Lascio a chi vorrà leggere il libro di Colozza la scoperta delle implicazioni dell’interpretazione e applicazione di questi e di altri articoli del codice penale alla sorte dei via via più numerosi imputati del “7 aprile”. Mi limito solo a sottolineare che la stretta dello Stato seguita al caso Moro portò a un giro di vite e all’elaborazione di norme eccezionali tarate su articoli di un codice penale codificato entro il 1930 che spostava l’attenzione dal reato alla persona. Era un codice scaturito dall’ideologia autoritaria e dalla cultura giuridica di una dittatura di destra, non di una democrazia come era lo Stato italiano degli anni Settanta (eppure Toni Negri “riduceva l’Italia degli ‘anni di piombo’ a un simulacro di democrazia dove la sovversione non era stata causa d’instabilità ma reazione a un regime sostanzialmente illiberale”: lo evidenzia Colozza a p. 283).
Inoltre, molti dati ricuciti insieme opportunamente da Colozza attraverso una ricerca capillare su fonti di prima mano e altre di variegato genere ricordano un dato di fatto. Nonostante l’inasprimento delle misure contro gli imputati del grande processo politico “7 aprile”, la contestazione e perfino la lotta armata nei confronti di coloro che venivano ritenuti “nemici del popolo” non cessarono, pur diradandosi progressivamente e inevitabilmente. Per esempio, il 27 marzo 1985 l’assassinio in pieno giorno nel parcheggio della città universitaria di Roma “La Sapienza” da parte di un commando delle BR del professore di Economia Ezio Tarantelli ne è un emblema. Il reato contestato dalle BR al professore era “di aver collaborato in quota Cisl al progetto governativo di taglio della cosiddetta ‘scala mobile’. Un nemico del popolo, dunque, sotto le eufemistiche spoglie di un tecnico di formazione cosmopolita intento a calmierare l’inflazione e favorire l’economia di mercato” (p. 236).
Immaginate che nell’Italia di oggi, colpita drammaticamente più di allora dall’inflazione e dal mancato adeguamento dei salari al costo della vita, si costituisca una contestazione così ampia e sentita da confluire addirittura in banda armata ai danni di qualche mio collega intento a servire il Governo per trovare la maniera legale migliore possibile per rendere i poveri ancora più poveri e per trasformare i borghesi e i piccolo borghesi in proletari. Si tratta di una possibilità non solo remotissima, ma inattuabile (per fortuna, naturalmente, dato che il ricorso alla violenza fu, allora, l’esito sbagliato di una causa che, forse, avrebbe potuto avere forme civili e pacifiche di contrattazione collettiva). Tuttavia è possibilità remotissima pure che oggi interi gruppi di sfruttati, di disgraziati, di immigrati siano sostenuti da folti gruppi di intellettuali che diano loro le parole per reclamare inclusione sociale e condizioni di lavoro e di vita dignitose.
Questo paese pare ormai rassegnato a essere vessato dalle ragioni dei potenti e del capitalismo sfrenato che negli anni Settanta e Ottanta alcuni professori e molti sognatori che si trasformarono in criminali provarono ad arginare. Lo ha raccontato benissimo Marco Bellocchio (immenso e sagace osservatore degli anni di piombo fino a Esterno notte) in un documentario che andò in onda sabato 11 ottobre 1995 su RAI 3: Sogni infranti (ragionamenti e deliri) (non lo trovate nelle teche RAI ma su you tube: https://www.youtube.com/watch?v=bH0PByGrskw&t=10s). Tra le altre cose, Bellocchio presta attenzione al “processo proletario” intentato dalle BR a Roberto Peci, condannato a morte e giustiziato perché fratello del traditore Patrizio Peci, il primo “pentito” delle BR che in carcere collaborò subito, fornendo informazioni che portarono alla strage di via Fracchia a Genova (tanto nota e controversa da essere evocata anche in un racconto noir del secolo scorso, La linea dell’orizzonte che Antonio Tabucchi pubblica nel 1986 mentre insegna all’Università di Genova. Colozza in “L’affaire 7 aprile” parla di Peci e della strage di via Fracchia alle pp. 95-96 e 179).
Soprattutto, in Sogni infranti Bellocchio sollecita il racconto di Enrico Fenzi, uno dei professori universitari coinvolti nei processi “7 aprile”. Professore di Letteratura italiana all’Università di Genova e ancora oggi, dopo la latitanza, il carcere, la dissociazione, riconosciuto da molti colleghi, coetanei e più giovani, come raffinato studioso di Dante e Petrarca. Fenzi entrò nelle BR nel 1976 (Colozza ne scrive alle pp. 108, 318 n. 103), fu arrestato a Milano nel 1981 con Mario Moretti, si dissociò dalle BR nel 1982, fu in libertà provvisoria dal 1985 al 1994. In questa fase ha ripreso gli studi accademici e ha pubblicato Armi e bagagli. Un diario dalle Brigate Rosse (Genova 1987), l’unico libro sulla militanza e sulla carcerazione dovuto a un esponente di primo piano delle BR che abbia anche una sostenuta qualità linguistica e letteraria.

Enrico Fenzi, Armi e bagagli. Un diario dalle Brigate Rosse, Genova, Costa & Nolan, 1987

Francesco Petrarca, Il mio segreto, a cura di Enrico Fenzi, Milano, Mursia, 1992
Qualcuno di voi, arrivato fin qui, si sarà chiesto perché mai una storica dell’arte scrive una recensione di un libro di storia politica e giuridica. Potrei circoscrivere le ragioni a una certa tradizione di area accademica: per dirne una, di “Arte e linguaggio della politica” (Firenze, S.P.E.S., 1978) si è occupato con acume Francis Haskell, lo storico dell’arte che a metà Novecento ha cambiato e ampliato il modo di intendere il mestiere che faccio. Haskell non tralasciava (quasi) nulla che potesse ricostruire la storia così com’era stata e, non a caso, preferiva definirsi “storico” tout court (ai libri di Haskell la rubrica ha dedicato parte dell’articolo del 15 settembre 2022: https://beemagazine.it/storie-dellarte-e-donne-istruite-libri-film-maestre-e-maestri-opere-darte-per-cittadine-indipendenti/).
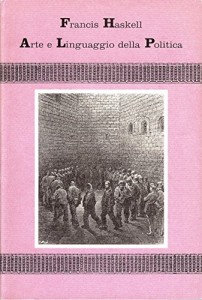
Prima ancora di essere una storica e una professoressa universitaria sono una cittadina, e dunque nulla del mondo in cui vivo mi è estraneo. Poi ci sono sia la mia storia familiare sia il modo in cui mi interrogo sulla tradizione e l’evoluzione del mio mestiere. Sono nata in un contesto in parte contadino, in parte operaio-proletario, in parte di artigiani o professionisti emigranti dal quale sono scaturiti, in tre diverse generazioni e per restare nel seminato, tre avvocati e una magistrata; io stessa ho mancato di diventare un’avvocata. Fino ai vent’anni pensavo che il mio lavoro di scrittrice in ambito culturale e creativo sarebbe stato un altro, poi mi è capitato presto di potermi formare allo scopo di diventare una studiosa e insegnante di storia dell’arte nell’università pubblica. Faccio lo stesso mestiere di alcuni degli imputati del “7 aprile” ma in un contesto sociale profondamente diverso, per giunta ora con un governo dichiaratamente di destra neofascista diverso da quello contestato negli anni di piombo.
La forma possibile della contestazione oggi unisce l’impegno di alcuni che scrivono e/o insegnano a quello di alcuni artisti che anche oggi stanno saldamente nel proprio tempo e conoscono la storia, elaborando le fonti per avvicinarsi alla verità e parlarne al maggior numero di persone possibile. La ricerca dei fatti che, ricomposti in un libro, in un articolo (e, aggiungo, in una drammaturgia, in un film) offrono un’idea che sia il più vicina possibile alla verità è stata riconosciuta da Tomaso Montanari come obiettivo comune (in Io sono (e resto) Giorgia, uscito su “Il Fatto Quotidiano” e poi sul blog “Volere la luna” qui: https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2023/08/30/io-sono-e-resto-giorgia/): “Per chi studia, legge, scrive sui giornali senza padroni, missioni o doppi fini, l’unica tattica è cercare di dire la verità: e “la verità spiacevole, nella maggior parte dei luoghi, è di solito che ti stanno mentendo. E il ruolo dell’intellettuale è tirar fuori la verità. Tirar fuori la verità, e poi spiegare perché è proprio la verità” (Tony Judt)”.
Mentre chiudo questo articolo si parla e si legge di continuo dell’aumento dei poveri che muoiono sul lavoro in condizioni degradanti per qualunque uomo e del rifiuto fermissimo di predisporre l’accoglienza e l’inclusione per coloro che arrivano in Italia per migliorare la propria vita, sperando di fondersi con chi c’è già, come è sempre successo nella storia passata, ovunque, a dispetto di razzismi e diffidenze.

Matteo Garrone sul set di “Io capitano” da lui diretto. Produzione: Archimede, Rai Cinema, Tarantula, Pathé, Logical Content Ventures, RTBF, VOO, BeTV, Proximus, Shelter Prod(Italia,Belgio 2023)
Ai tempi di Sacco e Vanzetti in America, come oggi in Italia, gli immigrati, i poveri, gli anarchici e chi vive la propria vita familiare e privata diversamente dai dettami e dalle ideologie governative sono considerati nemici e contro di loro si adottano misure (di respingimento, detenzione o di riduzione dei diritti) che appaiano esemplari per la comunità civile. A parlare a favore di queste persone e a dispetto di un nuovo “diritto penale del nemico” declinato in tante nuove forme c’è qualche mio collega e c’è anche qualche artista: ancora una volta un film, Io capitano di Matteo Garrone (premiato con il Leone d’argento per la migliore regia al Festival del cinema di Venezia 2023 e attualmente nelle sale), indica in modo asciutto la strada del buon senso e dell’accoglienza. Io capitano mostra che chi arriva qui sperando di migliorare la propria vita lavorando affronta il mare e, spesso, atroci sofferenze convinto che “si alza il vento, bisogna provare a vivere”.
Floriana Conte – Professoressa associata di Storia dell’arte a UniFoggia (floriana.conte@unifg.it; Twitter: @FlConte; Instagram: floriana240877) e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia







