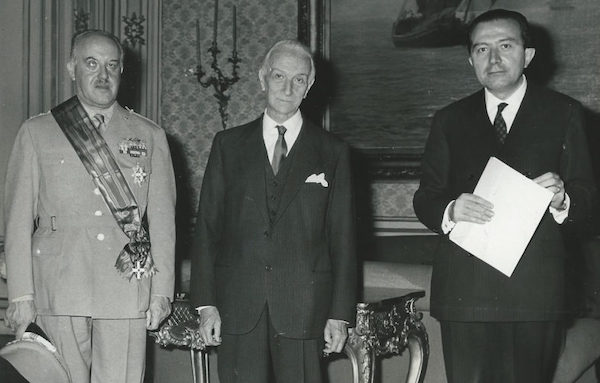Dai dati ufficiali sulla previdenza e assistenza pubbliche, Alberto Brambilla, uno dei pochi davvero esperti in materia, ha tratto questa sconcertante conclusione: “Avevamo 2,1 milioni di poveri assoluti nel 2008 quando spendevamo 73 miliardi per assistenza sociale. Oggi ne spendiamo 160 e i poveri assoluti sono 5,6 milioni e quelli relativi ben 8,6 milioni, ma non troviamo 170mila lavoratori per agricoltura e turismo” (Corriere della Sera, 29 aprile e 13 maggio 2024). C’è molto che non va in Italia, e forse pure qualcosa di marcio: più spendiamo per sovvenire i poveri, più i poveri aumentano di numero!
Alla luce di questi dati Alberto Brambilla pone a sé stesso ed al Governo la seguente, cruciale domanda: “Ha ancora senso parlare di riduzione del carico fiscale e di redistribuzione per mitigare le disuguaglianze? O sarebbe meglio aumentare i controlli, parlare di doveri e non solo di diritti e prendere in carico i cittadini bisognosi per assisterli al fine di farli uscire dalla povertà?”
Esiste la povertà vera. Tuttavia è plausibile che non esista la povertà finta? Il problema è la povertà oppure i poveri? Le politiche per alleviare la povertà non comportano forse un’aliquota di poveri incentivati a beneficiarne? Si deve escludere la presenza di un “partito” che prospera nell’agitare e nel lasciare sempre sanguinante la piaga della miseria? Può essere utile sospendere l’Isee e valutare con obiettività lo stato di bisogno per aiutare soltanto i veri bisognosi?
La “lotta alla povertà” praticata in Italia (dove il potere pubblico “lotta” sempre contro qualcosa per accreditarsi nella veste di risolutore dei problemi sociali) pare, ahimè, perdente, non solo alla luce dei risultati numerici suddetti, ma anche perché viene praticata a danno di quelli che forniscono i mezzi, cioè i contribuenti. Sempre Alberto Brambilla ci ricorda e ricorda all’autorità governante (il complesso Parlamento-Governo) che la quota pro-capite per sanità, assistenza, istruzione eccetera ammonta a 14.500 euro, mentre i cittadini che versano più di 15 mila euro di tributi sono pochissimi. Solo il 5% paga, quasi,
per tutti! Insomma, sono i molti beneficiari che prendono dai pochi paganti.
Questa situazione richiama alla mente il vocabolo che nella seconda metà del XX secolo accendeva polemiche roventi ed adesso è scomparso, chissà perché. Intendo l’assistenzialismo, che può essere esplicito (come mantenere in vita una fabbrica fallimentare per “motivi occupazionali”), fraudolento (come le pensioni ai falsi invalidi), indiretto (come equo canone e equo prezzo). L’assistenzialismo del XXI secolo è diventato programmatico. Costituisce la parte cospicua della spesa pubblica e, quanto al tema della povertà, ha assunto il carattere imprescindibile dell’obbligo sociale, sebbene socialmente ingiusto alla luce di quel 5% e degli inintenzionali effetti negativi. Inoltre, ed è il punto cruciale, l’assistenzialismo, anche riferito alla povertà, se non è ben calibrato, comporta gravi rischi per la società che, giustamente devota alla causa dei poveri veri e propri, debba perciò mantenersi concretamente attrezzata con i mezzi indispensabili ad aiutarli.
In un libro fondamentale, un classico dedicato alla polis, troviamo un giudizio sulla crisi della democrazia ateniese che si attaglia all’oggi: “Sempre insufficiente, continuamente aumentato, il fondo di assistenza sociale corrompeva il regime, dissipava in sportule mezzi finanziari necessari ai servizi di essenziale importanza, mandava in rovina il Tesoro e la Città. La responsabilità del male era nell’Ecclèsia (assemblea politica). Su questo punto abbiamo un testimone insospettato: l’avversario di Demostene, Eschine. In un momento d’indignazione più interessata che virtuosa, l’abile oratore trovò la parola giusta. Parlando dell’adunanza in cui gli uomini politici si facevano decernere ogni sorta di onori: “Se ne esce – disse – non
come da assemblee deliberative, ma come da riunioni di azionisti dopo la distribuzione dei profitti.” Sì. La
repubblica era diventata veramente un éranos, una società di mutuo soccorso chiedente agli uni i mezzi per provvedere al mantenimento degli altri. Per un capovolgimento singolare delle relazioni che in passato sembravano naturali, non più i cittadini dovevano adempiere i loro doveri filiali verso la Città, ma la città era tenuta ad osservare l’obbligo alimentare verso i cittadini, sì che mai la Città parve così potente come nel tempo in cui gli individui, sfruttandola, ne preparavano la rovina” (Gustave Glotz, “La Città greca”, 1948, pag.298).
La lotta alla povertà sconta poi il pregiudizio verso la ricchezza, mentre l’osservazione della realtà in ogni Paese dimostra indubitabilmente che, dove i ricchi sono più ricchi, i poveri sono meno numerosi e meno poveri. Se i dati sulla povertà assoluta e relativa fossero esatti alla virgola, l’Italia somiglierebbe troppo da vicino alla morente democrazia ateniese. È credibile che in Italia esistano 14,2 milioni di poveri che necessitano di una qualche forma di sostegno erariale e, ciò nondimeno, aumentino al crescere della spesa pubblica per il loro mantenimento?
Oltre il peso finanziario, per di più aggravato dal debito pubblico di circa tremila miliardi (cifra impronunciabile se espressa in lire!), gli altri aspetti connessi e implicati da tale politica contro la povertà riguardano un carattere essenziale della nazione, che sembra adagiata sulla sussistenza e la sopravvivenza anziché agitata dalla tensione creatrice e proiettata verso l’intraprendenza in ogni senso. Inoltre, anche i dati statistici sulla crescita degli occupati, che dovrebbe implicare una riduzione delle fasce di povertà, non sono significativi a riguardo perché non vi incidono. Infine, i dati sul valore reale delle retribuzioni dimostrano che non aumenta apprezzabilmente da vari lustri e forse diminuisce addirittura, secondo
recenti rilevazioni.
Mettendo insieme tutti questi elementi di giudizio sembra doversene ricavare che la povertà lamentata, per quanto all’apparenza meno diffusa di quella risultante dalle statistiche e dagli Isee, in buona sostanza sia dovuta alla stagnazione della produttività del sistema economico, mantenutasi pressoché costante dall’inizio del secolo. L’efficienza del processo produttivo privato e pubblico non è cresciuta in modo da incrementare le retribuzioni lorde ad un tasso annuale superiore al tasso d’inflazione. La curva piatta della produttività è determinata dalla relativa concorrenza imperfetta che impedisce la migliore allocazione delle risorse materiali ed immateriali, cioè la creazione di ricchezza che sola elimina la miseria assoluta e allevia la povertà relativa.
In conclusione, come i ministeri contro la siccità non generano pioggia, così le politiche contro la povertà finiscono per danneggiare gli stessi veri poveri se attuate da governanti e burocrati atteggiati a “do-gooders”, benefattori a prescindere.
Pietro Di Muccio de Quattro