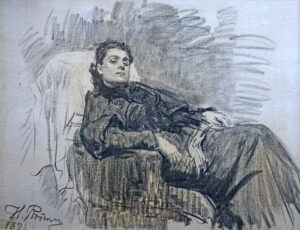Si può elucubrare sul saluto a mano tesa di Elon Musk. Si può speculare come teologi bizantini sullo scadere di X (fu Twitter), o sulla scelta (interessata) di Zuckerberg riguardo alle policy di moderazione dei contenuti. Si può deprecare lo stile-Trump ogni volta che apre bocca. Ma in questa innegabile e strana accelerazione storica un fatto è li davanti a noi. Il politicamente corretto e il linguisticamente corretto sono in fase calante. Momentanea? Definitiva? Non sappiamo. Ma di certo chi si occupa di comunicazione a tutti i livelli: politico, sociale, economico, culturale, dovrà tenere conto di una sensibilità comune che sta cambiando.
La fase post Covid è esaurita, non “ne usciremo migliori”
Certo non da ora, e non è detto che sia per colpa di Musk, Trump, o Zuckerberg. È almeno dalla fine dell’emergenza Covid che qualcosa in ambito delle forme di rappresentazione si muove in direzione contraria alla correttezza politica e ai suoi simboli: narrazione eticizzante, linguaggio emotivo/empatico, storytelling autobiografico, inclusività. Elementi usati (e abusati, ammettiamolo) durante i giorni distopici del primo lockdown planetario, correva l’anno 2020 (ricordate gli spot pubblicitari di quel periodo?). Linguaggi trasferiti poi sulla transizione ecologica che doveva essere cardine della rinascita post pandemica, salvo che le cose, per una serie di fatti piuttosto noti e gravi, non sono andate esattamente come previsto. Non tutto è in risolvibile in un “ne usciremo migliori” o in un “salveremo il mondo”. E non tutto è solubile in una scelta di parole non offensive di questa o quella minoranza.
I paradossi del linguisticamente corretto
A proposito di parole: l’aspetto linguistico del politicamente corretto si presta a paradossi imbarazzanti. E il suo fondamento “filosofico” è discutibile. Senza entrare in luoghi comuni (la vulgata del “non si può dire più niente”, dell’”ultima follia woke”) e senza insistere sugli aspetti più sensazionalistici del problema (come il fatto che in molte multinazionali nella corrispondenza interna è vietato usare “he” o “she”, si usa il “them” per non entrare nel merito dell’identità sessuale dei destinatari) bisogna almeno rilevare che il linguisticamente corretto pone enormi problemi.
Nel Regno Unito ci sono state sentenze basate sul fatto che la presunta vittima “si fosse sentita offesa” per le parole del presunto aggressore. Dal punto di vista legale la percezione (il “sentirsi”) viene considerata più importante dell’oggettività. Un mostro giuridico.
Ma anche dal punto di vista del fondamento da cui trae origine il linguisticamente corretto sconta enormi paradossi. La “svolta linguistica” delle filosofie primonovecentesche nemmeno si sognava una identificazione in toto di lingua ed essere, che, oltre alle nelle forme più radicali di wokismo si dà solo nella pratica magico-religiosa . Cambiare le cose cambiando le parole, non c’è una risonanza di pensiero magico, se non di “effatà”, in tutto questo? Gli ultimi metafisici sono i linguistici?
Ma scendiamo in fretta dalle sfere mistiche. È stato il presidente francese Macron, nel 2023, a parlare in modo netto contro il linguaggio inclusivo (“Non abbiamo bisogno di aggiungere puntini o trattini”) rimarcando una identità francese ed europea rispetto alla tendenza di origine anglosassone.
Meno etica, più ironia: l’eclisse del marketing valoriale
Contemporaneamente anche il linguaggio delle rappresentazioni si andava spostando verso forme più elastiche e ironiche. Meno nella cultura ufficiale, che ha un angolo di virata piuttosto largo, più nelle forme brevi dei social, che adesso sono pieni di meme e scene politicamente scorrette che ironizzano su razze culture, orientamenti sessuali. Siamo sicuri che sia solo un’invasione di maranza digitali o un riflesso della mala-educazione trumpiana? Anche il linguaggio pubblicitario è sempre più giocato sull’ironia, e c’è chi parla di eclisse del marketing valoriale: da poco diverse aziende, da Jack Daniel’s ad Harley Davidson, hanno deciso di focalizzarsi sulla loro missione primaria: vendere prodotti senza necessariamente appoggiare contenuti sociali.
E torniamo alla questione Zuckerberg. Qualche giorno fa il Ceo di Meta ha annunciato che sarebbero cambiate le modalità di moderazione. Non più società esterne (o aggregazioni di società) come Pointer, ma “community notes” nelle quali i post più discutibili vengono valutati dagli utenti. Ora, la moderazione di contenuti è il problema principale di qualsiasi piattaforma informativa: niente di meno che motivo per il quale i media si chiamano media: servono a mediare. Il cuore del problema informativo attuale: le piattaforme sono editori, ma di fatto senza responsabili editoriali. In breve sono editori che si negano come editori. Ed è questo il loro grande, strutturale, buco nero. Che permane, qualsiasi decisione abbia preso Zuckerberg a riguardo. Una società di controllo inappellabile equivale a un utente inafferrabile. Ora, la decisione di Meta è un modo per ingraziarsi Trump e Musk o la presa d’atto che una moderazione basata su “apostoli della verità” (bella espressione di Matteo Flora) non era più, banalmente, praticabile? Forse entrambe le cose. Fatto sta che qualcosa nel mood comunicativo sta cambiando.
Bruno Giurato – Giornalista