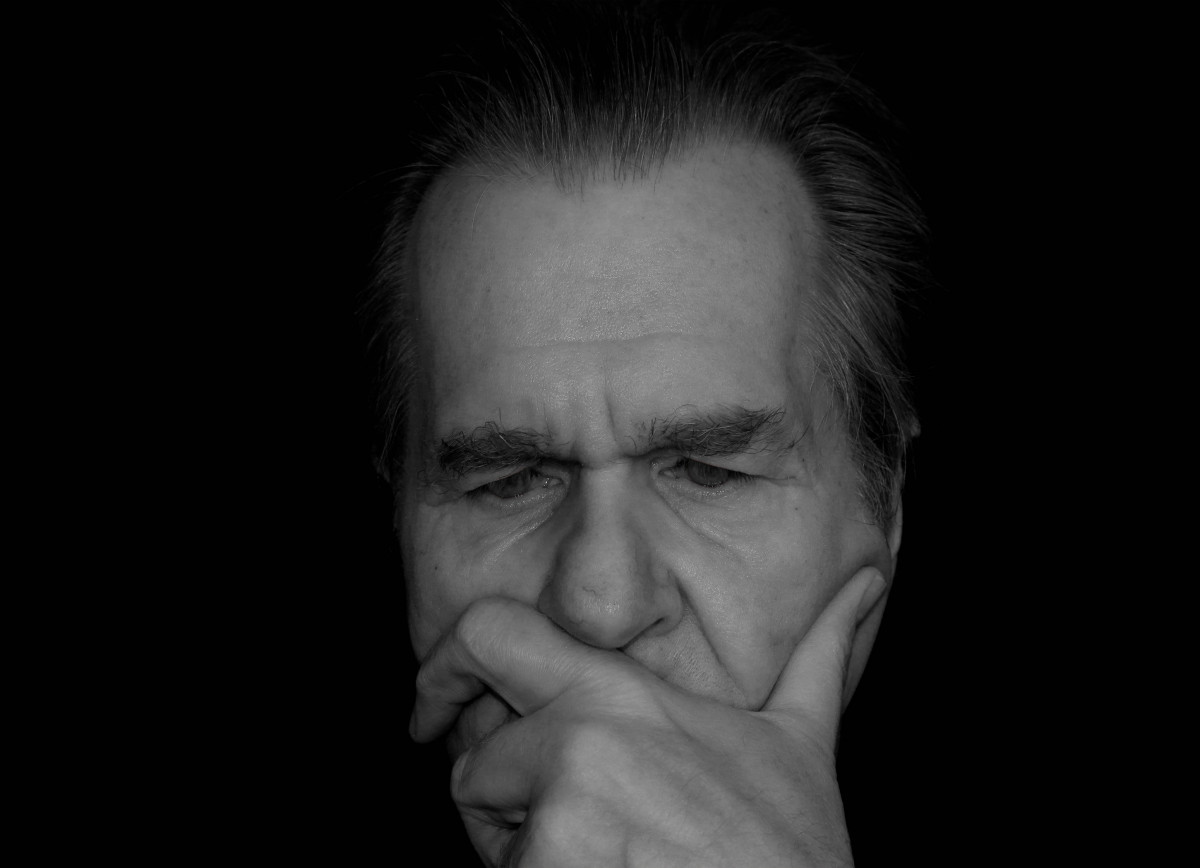Le mostre d’arte e il teatro, si sa, sono contigui: in entrambi i casi si entra in luoghi allestiti per un evento specifico, per una durata limitata, per una fruizione collettiva e per un’esperienza che si vive solo lì, in un preciso momento. La contiguità tra le mostre d’arte (uno dei mezzi più pervasivi dell’industria spesso pseudoculturale da luna-park dei nostri tempi) e teatro (risorto, almeno per partecipazione del pubblico, dopo la pandemia) favorisce le riflessioni su una forma di arte visiva come la Performance Art, alla quale è dedicato dal 2006 a Roma il Festival di Arti performative “Short Theatre”, in corso fino al 17 settembre. “Short Theatre” 2023 è dedicato al tema “Radical Sympathy”, a partire da un episodio che coinvolse il pubblico della celeberrima attrice Sarah Bernhardt durante una sua realistica recita della morte della “signora delle camelie” (l’episodio e il programma del Festival sono qui. “Short Theatre” si sta svolgendo sia al Teatro Argentina e al Teatro India sia in spazi assimilati al teatro ma che non sono teatri: “una scatola nera, un prato, la strada, una stanza per l’ascolto”, un ex mattatoio.

Achille Melandri, Sarah Bernhardt con un busto da lei realizzato, fotografia del 1879 ca. Achille Melandri, Sarah Bernhardt nella bara che teneva nel salotto di casa, fotografia (s. d.)
Basta leggere la presentazione del Festival romano e di altri festival dedicati alla Performance Art per constatare che, fin dal titolo o dalla sinossi, si tratta di una forma d’arte in competizione con il teatro. Infatti dagli inizi la Performance Art è debitrice del teatro sui piani espressivo, iconografico, linguistico, espositivo / allestitivo. Attori professionisti e artisti performativi hanno condiviso spesso nel Novecento, oltre ad alcuni spazi di lavoro, proprio i lemmi “performance”, “performante” e “performativo” nel lessico tecnico di coloro che scrivono e parlano della qualità del loro lavoro. Attori professionisti e artisti performativi condividono spesso (con mezzi e scopi diversi) anche un uso del corpo portato alle sue estreme possibilità di tensione, movimento, trasformazione, lacerazione, peso e dimensioni.
Il settore della Performance Art più indebitato con il lavoro degli attori professionisti, la cosiddetta “Body Art”, era fin dagli esordi “teatro, non spettacolo”. Lo ha assicurato Lea Vergine, la critica e studiosa d’arte contemporanea (mai incardinata in un’università) che ha promosso la Body Art in Italia. E “che ci fosse una preparazione lo si dava per scontato, come per Carmelo Bene o per Malina”, ha chiarito Vergine quando ha fatto un bilancio della propria esperienza di studiosa di Performance Art (nella conversazione con Ester Coen, “Schegge. Lea Vergine sull’arte e la critica contemporanea”, Milano 2001, pp. 37-35).

Lea Vergine (a destra) con Gina Pane (seduta alla sua destra) durante una presentazione del libro “Il corpo come linguaggio (La ‘Body-art’ e storie simili)”, nel 1974
Fu proprio Lea Vergine a storicizzare per prima, a caldo e a modo suo, la Performance Art fondata sull’esclusivo esercizio sul corpo e sulla sua teatralizzazione. Affidò la storia per immagini e per brevi didascalie/schede al primo libro italiano sul tema, “Il corpo come linguaggio (La “Body-art” e storie simili)”, uscito a Milano nel giugno 1974. Per il titolo, Lea Vergine scelse l’anglismo “Body Art” al posto delle perifrasi “arte di comportamento” o “arte del corpo” che in Italia in ambito accademico, critico, espositivo e di mercato si usano come possibile alternativa fino al giugno 1977. Si badi bene: nel libro nel cui titolo e nel cui sottotitolo Lea Vergine vara la fortuna delle etichette “corpo come linguaggio” e “Body Art”, non compare mai la parola “performance”.

C’è fin da subito il problema di distinguere ciò che fanno con il corpo gli artisti performativi negli “spazi alternativi” da quello che fanno gli artisti che recitano in prosa, che cantano, che ballano recitando sui palcoscenici: tuttavia, nella pratica la distinzione permane raramente come regola ferrea o, comunque, per tempi relativamente brevi e soggiace a ragioni economiche.
Nonostante la condivisione del lemma “performance” dal 1977, teatro e Performance art sono diversi in primo luogo per la formazione e la professionalizzazione degli artisti, poi per via dei destinatari delle rappresentazioni. La Performance Art ha un pubblico che non sa quasi mai cosa aspettarsi e che deve occupare il proprio posto in uno spazio non uguale per tutti; il teatro invece si pone “un’ipotesi di pubblico” fatto di singoli spettatori che si preparano a una forma di coinvolgimento in uno spazio preassegnato: “il progetto di uno spettacolo è sempre un’ipotesi costruita su uno spettatore. Naturalmente, siccome il pubblico è formato da più spettatori, può capitare che l’ipotesi sia giusta per la settima fila, ma non per l’ottava”: così la pensava Luca Ronconi, maestro del teatro di regia italiano con Massimo Castri e Giorgio Strehler (la citazione viene dalla bella autobiografia uscita per Feltrinelli: Luca Ronconi, “Prove di autobiografia”, raccolte da Maria Grazia Gregori, a cura di Giovanni Agosti, Milano 2019, pp. 120 e 143; si veda anche p. 26).
La Performance Art sviluppata in Europa negli anni Sessanta del Novecento di fatto ha interessato prevalentemente un pubblico superficiale, con un’istruzione media o bassa, magari più incline a comprendere il “teatro della chiacchiera” e il “teatro del gesto e dell’urlo”; tale pubblico anche oggi è quasi sempre distinto da quello interessato all’arte antica e moderna e al teatro di regia e di parola.
La figura di un’artista vivente come Marina Abramović mette spesso insieme, invece, i vari tipi di spettatori: l’artista è emblematica del genere soprattutto perché è ancora attiva, tanto nota da essere stata oggetto di parodie in film (“La grande bellezza”) oltre che in serie televisive (“Sex and the city”) e programmi satirici e perché alle conseguenze delle mostre e delle esibizioni allestite in Italia ha legato il “cursus honorum” della sua carriera, culminante nella retrospettiva “Marina Abramović. The Cleaner” allestita tra 2018 e 2019 a Firenze.

Nella tradizione della Performance Art della quale Marina Abramović è la più anziana rappresentante in attività ci sono curiose tangenze, anche cronologiche, tra le messe in scena di opere storiche di Luca Ronconi e gli inizi e gli sviluppi delle performance di Abramović. Ma finora la storia dell’arte, la storia del teatro e la critica d’arte e teatrale hanno trascurato queste indubbie tangenze, perché le discipline sorelle spesso e volentieri non comunicano.
Eppure guardare alle cose in questo modo non è una forzatura, c’è un fondamento storico: per secoli gli artisti sono spesso stati contemporaneamente pittori o scultori, incisori, drammaturghi, poeti, scenografi e attori; Bernini e Salvator Rosa hanno lavorato così e molti altri artisti collaboravano quotidianamente con i letterati e gli studiosi di professione, spesso condividendo con loro seggi nelle accademie letterarie o aspirando a essi. Anche oggi in certi casi felici non è del tutto scomparsa tale forma di poliedricità e di collaborazione.
Ecco, dunque, qualche dato. Innanzitutto, nella formazione di Abramović durante gli anni di Accademia di Belle Arti a Belgrado assume rilievo proprio il teatro. Marina, studentessa di pittura, frequenta quotidianamente un regista teatrale attivo anche a Zagabria e al seguito del quale la ragazza aveva preso parte, da spettatrice, anche al Festival internazionale del Teatro: il regista strutturalista e artista performativo croato Tomislav Gotovac. Questi nel 1962 aveva realizzato “Showing Elle Magazine”, che oggi è possibile incasellare nel genere che poi sarebbe stato definito “performative photography”, cioè la fotografia ottenuta da una performance realizzata per essere fotografata, quasi sempre con autoscatti (l’opera, in tal caso, è la fotografia ottenuta).

Tomislav Gotovac, Showing Elle Magazine, particolare, sei stampe su carta alla gelatina ai sali d’argento, 39.9 × 29.9 cm, 1962, New York, Museum of Modern Art, inv. 117.2014.a-f (qui la scheda dell’opera nel sito del MoMA : https://www.moma.org/collection/works/173436
Gotovac era stato uno dei protagonisti del primo “happening” realizzato a Zagabria nel 1967, molto più cupo dei precedenti americani degli anni Cinquanta e più affine allo spirito delle provocazioni dadaiste. Nel 1971 Abramović frequentava l’ultimo anno di Accademia di Belle Arti e Gotovac fu il regista di una performance collegata all’annuale Festival internazionale del teatro di Belgrado: uno studente rompeva uova sul corpo di una modella nuda nello studio messo a disposizione da Abramović, che faceva parte del pubblico e che trovò inizialmente “stupido” tutto quanto. Dopo un anno Abramović cambiò idea, si liberò della pittura (che praticava con risultati non eccellenti) e cominciò a dedicarsi totalmente a progetti di performance. Forse a tale decisione contribuì anche il rapporto di amicizia con Gotovac, che studiava alla facoltà d’arte drammatica e che poi divenne professore universitario nel dipartimento di cinematografia dell’università dove insegnava anche il fratello di Abramović.
Stando all’autobiografia (Marina Abramović, “Attraversare i muri. Un’autobiografia”. Traduzione di Alberto Pezzotta, Milano, Bompiani, 2018) e alla biografia autorizzata dell’artista (migliore dell’autobiografia dal punto di vista della godibilità letteraria (James Westcott, “Quando Marina Abramović morirà”. Traduzione di I. Inserra e M. Mancini, Monza, Johan & Levi, 2011), Gotovac fu responsabile di una capillare educazione cinematografica di Marina, “introducendola alla storia del cinema” e portandola “regolarmente al cinema Kinoteka”. Abramović ha raccontato che Gotovac, oltre a spiegarle tutto su scenografia, montaggio ecc., “conosceva ogni singola scena e ogni singolo personaggio. […] Sapeva i nomi di tutti gli attori e persino delle comparse dei film di Kurosawa. […] Mi fece capire cosa significa davvero guardare”. Riassumendo, la decana della Performance Art ha imparato a guardare con occhi da artista andando al cinema con un regista teatrale (di questo episodio ho scritto nel libro “Le conseguenze delle mostre. II. Dare forma al vuoto. La tradizione nella Performance Art”, Roma 2021, p. 200).
Non è inoltre trascurabile che fin da giovane Abramović avesse già dimestichezza anche con il tipo di teatro sperimentale che piaceva a Luca Ronconi. Nel 1976, vicina ai trent’anni, Abramović partecipa per la prima volta alla Biennale di Venezia con Ulay, nel periodo in cui Ronconi dirige il Settore Teatro della Biennale, dal 1974 fino alle dimissioni il 4 luglio 1977. Nel 1976 Ronconi fa rappresentare a Venezia spettacoli di Peter Brook, Victor García, Ramón María del Valle-Inclán, Meredith Monk, ma soprattutto “Einstein on the Beach” di Philip Glass con la regia di Bob Wilson, sul quale nel 1988 lo stesso Ronconi esprime pubblicamente il proprio pensiero, ritenendolo un “drammaturgo degli anni ’70 che sia anche un nostro contemporaneo”.

Una scena da “Einstein on the Beach”, opera in quattro atti di Robert Wilson e Philip Glass, Opéra Comique, Paris 1976, ph.: Philippe Gras
Negli anni Settanta Abramović conobbe Wilson quando questi “tenne una conferenza e una dimostrazione a un festival teatrale di Belgrado. Rimasi affascinata dal suo approccio al teatro […]. Trentasette anni dopo avevo un’idea da proporgli. […] ‘The Life and Death of Marina Abramović’”: un vero e proprio spettacolo teatrale con sé stessa protagonista accanto a Willem Dafoe.

Una scena di The Life and Death of Marina Abramović, di Robert Wilson e Marina Abramović. Prima (in inglese): 9 luglio 2011 al Manchester International Festival, The Lowry, Manchester, United Kingdom (https://robertwilson.com/life-and-death-of-marina-abramovic)
La Performance Art, dunque, comincia, e spesso finisce, con il palcoscenico. Una carrellata sulle tangenze storiche e geografiche tra le rappresentazioni di spettacoli diretti da Luca Ronconi e la formazione e l’attività giovanile di Marina Abramović tra la ex Jugoslavia e l’Italia è ulteriormente eloquente in tal senso.
Luca Ronconi era ben noto nelle città slave in cui è cresciuta e si è formata Abramović. Il I9 maggio 1969 al Teatro Komedija a Zagabria, la città in cui Marina si perfezionò, Ronconi mette in scena la prima di “Traumdeutung. Psychodramme pour quatre chœurs et quatre instruments” di Vinko Globokar su libretto del professore poeta Edoardo Sanguineti (Globokar era anche l’autore degli effetti musicali della “Fedra” di Seneca tradotta da Sanguineti con i costumi di Enrico Job, marito di Lina Wertmüller, la cui prima fu al Teatro Valle a Roma il 10 gennaio 1969).
Il 20 settembre 1972 nel Filmskijgrad Atelier 3 (BITEF) a Belgrado Ronconi mette in scena la prima dell’”Orestea” di Eschilo accostando in sette ore tre tragedie (“Agamennone”, “Le coefore” e “Le eumenidi”) con la scenografia di Enrico Job. Il principio della resistenza del corpo in scena in uno spazio chiuso davanti a un pubblico, anche arrivando a conseguenze estreme a causa di tempi di esibizione dilatati, è alla base di tutta la prima fase della carriera di Marina, da sola e con Ulay.

“Orestea” (“Agamennone”, “Le coefore” e “Le eumenidi”), regia: Luca Ronconi. Prima al Filmskijgrad Atelier 3 (BITEF), Belgrado, 20 settembre 1972. Durata: sette ore

Marina Abramović e Ulay, “Nightsea Crossing”, 1981-1986 (1986). Performance, New Museum, New York, USA. Durata: circa sette ore (coincidenti con l’orario di apertura del museo)
Il 4 luglio 1969 nella chiesa di San Nicolò a Spoleto, Ronconi mette in scena la prima dell’”Orlando furioso” al XII Festival dei Due Mondi. Ronconi non era inizialmente convinto dall’”idea di uno spazio-circo” che gli aveva suggerito Edoardo Sanguineti. Passa quindi all’idea di uno spettacolo governato dalla simultaneità: “là c’è Angelica nuda, qui Orlando in calzamaglia e il pubblico decide di andare da una parte o dall’altra”, in mezzo a scenografie e macchine da presa.

“Imponderabilia” di Marina Abramović e Ulay alla Settimana Internazionale della performance, Galleria Comunale d’arte Moderna Bologna, 1977 (al centro nel pubblico c’è Francesca Alinovi)

“Orlando furioso”, regia: Luca Ronconi. Prima nella chiesa di San Niccolò (Festival dei Due Mondi), Spoleto, 4 luglio 1969

Marina Abramović, “Freeing the voice”, 1975, Belgrado, Studentski Kulturni Centar. Durata: 3 ore
Nel 1975 Ronconi ricava dallo spettacolo una miniserie appositamente adattata al pubblico televisivo della RAI. Due anni dopo, il 3 giugno 1977 alla Galleria comunale d’arte moderna a Bologna durante la prima Settimana internazionale della performance organizzata da professori e ricercatori universitari attivi al DAMS, Abramović mette in scena con Ulay “Imponderabilia”, che ha lo scopo di accogliere i visitatori che entrano in galleria. Ogni visitatore può entrare da solo, passando tra Abramović e Ulay nudi, appoggiati agli stipiti della porta d’ingresso, costringendo il pubblico a entrare strusciando sui loro corpi scegliendo se stare di fronte a Marina nuda o a Ulay ugualmente nudo, mentre la performance viene registrata e fotografata. “Imponderabilia” farà la fortuna internazionale della coppia Ulay-Abramović, favorendo la progressiva identificazione dell’artista con la materia in cui va operando presso un pubblico vasto che cerca informazione e svago occasionali, non esperienze conoscitive che cambiano anima e corpo dopo avervi assistito. A Bologna l’idea di obbligare i visitatori del museo bolognese a scegliere se strusciarsi contro il corpo nudo femminile o maschile suscitò lo scandalo previsto, con l’intervento della questura (chissà se sollecitata preventivamente).

Illustrazione da “Imponderabilia” dalla recensione di Mario Perazzi, “La merce d’artista”, in “Corriere della sera”, 7 giugno 1977, p. 12
Ma se a Bologna nel 1977, infatti, si giocarono ufficialmente il passaggio lessicale da “arte di comportamento” a “performance”, insieme al passaggio dagli spazi alternativi al museo e al mercato, la Performance Art continuò a dovere al teatro italiano idee e fisionomia iconografica. La bibliografia scientifica non ricchissima sulla storia della Performance Art rinvia di consueto, e senza sbagliare, al teatro propriamente di avanguardia: Grotowski e il teatro povero, il Living Theater di Julian Beck e Judith Malina, Simone Forti presente a Roma.
Ma, come ho provato a mostrare, anche uno sguardo privo di barriere disciplinari al teatro di regia, che parte anche dalla letteratura per rovesciarla, rileggerla e innovarla, rivela sicuramente molto altro sulle fonti degli artisti performativi.
Quando a giugno del 1977 comincia la prima Settimana internazionale della performance alla quale Marina e Ulay portano “Imponderabilia”, in Italia non esiste ancora l’uso assoluto dell’anglismo “performance” per indicare l’arte presentata all’esposizione. La Settimana è la prima mostra collettiva di arte performativa (praticamente un ossimoro!) e ha per la prima volta la parola inglese “performance” nel titolo. Del Comitato fanno parte due allievi di Francesco Arcangeli, un professore allievo di Roberto Longhi che studiava con la stessa passione l’arte antica e l’arte contemporanea (e che infatti aveva curato per la Biennale di Venezia la mostra “Opera o comportamento”, in cui l’arte di “comportamento” era la “performance”).
Gli allievi di Arcangeli sono il professor Renato Barilli e la tormentata e brillante ricercatrice Francesca Alinovi (poi passata agli orrori della cronaca nera accademica e nazionale perché ammazzata da un suo studente e amante con modalità che oggi rientrerebbero a pieno titolo nell’elenco dei femminicidi, anche per il “victim blaming” immediato e persistente). La Settimana internazionale della performance ha il primato di avere introdotto per la prima volta in Italia, dentro una mostra collettiva in uno spazio istituzionale, l’arte immateriale che ha il corpo come materiale principale e il suo comportamento come iconografia, legando la manifestazione a una mostra-mercato di arte visiva tradizionale, “Arte Fiera” (quest’ultima si svolge ancora oggi a Bologna). A conferma del confine spesso indistinto tra teatro e performance, alla Settimana partecipano artisti come Leopoldo Mastelloni, Laurie Anderson, Fabio Mauri. Oggi forse solo il cinema di Davide Manuli ha riportato in vita questo abbattimento di confini: andate a riguardare l’esito, sottratto a ogni schema di genere, della collaborazione sul set di “Kaspar Hauser” tra attori (l’irregolare americano Vincent Gallo, un’inaspettata Claudia Gerini e uno dei pochi artisti italiani ai vertici qualitativi di teatro e cinema, Fabrizio Gifuni), una performance artist (Silvia Calderoni, che è presente in due appuntamenti al Festival romano “Short Theatre” in corso), uno scrittore (Giuseppe Genna, autore dei monologhi recitati da Gifuni in italiano regionale lucerino), una modella e attrice (Elisa Sednaoui).

Silvia Calderoni e Fabrizio Gifuni in La leggenda di Kaspar Hauser. Regia: Davide Manuli. Produzione: Blue Film, Shooting Hope Production, Fourlab (Italia, 2013)
Il catalogo della Settimana internazionale della performance esce un anno dopo la mostra, a conferma dell’ambizione alla serietà scientifica del lavoro su un argomento che si intendeva storicizzare (oggi i cataloghi sono spesso terminati prima degli allestimenti delle mostre). Nel libro (disponibile anche in una ristampa anastatica: “La performance oggi. Settimana internazionale della performance”, Bologna 2017). Francesca Alinovi affida alla scheda sulla performance di Stanislao Pacus, “Alla ricerca di una giovane che fu trovata in un chiuso”, una distinzione che conferma la labilità semantica della parola “performance” e il suo precipuo uso in ambito teatrale:
Quella di Pacus è stata una vera “pièce” teatrale, con tanto di scena, copione e attori professionisti che hanno recitato compiutamente la propria parte leggendo da tre vistosi leggii, come si addice ad una esibizione di perfetto gusto accademico. D’altronde il confine tra la “performance” e lo spettacolo propriamente teatrale è assai fluido e labile, come ci insegna anche la stessa parola “performance” che, nella lingua inglese, viene usata appunto eminentemente nel senso di “rappresentazione” teatrale.
Nel 1978 la variabilità linguistica e semantica del lessico si innesta su un dibattito in corso, quando insieme al catalogo della Settimana internazionale della performance esce “Performances. Happenings, Actions, Events, Activities, Installations…” che il gallerista milanese Luciano Inga-Pin definisce “una testimonianza e non certo un documento critico” delle circa quattordicimila performance a lui note dal 1960 al 1978. Il volume esce a giugno, con una copertina nera su cui sono montate otto immagini a colori da “Rhythm 0” eseguita da Marina Abramovic una notte del 1975 allo Studio Morra a Napoli. Nel primo dei sei paragrafi del saggio introduttivo “Performances, Le tecniche d’uso”, Inga-Pin distingue la performance degli attori da quella degli artisti:

“Le tecniche d’uso per la realizzazione di una performance sono generalmente condizionate dal soggetto. Tuttavia, anche nella molteplicità dei casi, esse sono ormai facilmente classificabili e presentano analogie comuni. […] Anche i termini finora adottati – performance, evento, azione ecc. ecc. – tendono sì a puntualizzare quella piuttosto che questa finalità ma lasciano in sospeso altri interrogativi. Forse siamo di fronte a un termine improprio che ha un senso se collocato nell’originario contesto teatrale e un altro se eseguito in una galleria d’arte o in uno spazio pubblico. […] Sul piano formale la performance che un artista esegue nello spazio di una galleria d’arte non si discosta poi molto da quella eseguita da un attore sul palcoscenico di un teatro. […] Se nel contesto di una galleria d’arte la performance resta tuttavia limitativa – il pubblico che vi assiste non è mai numeroso ed è costituito soprattutto da ‘addetti ai lavori’ – questo limite sottolinea comunque la natura stessa di una verifica che può attuarsi solo all’interno di un determinato evento culturale. Fuori risulterebbe incomprensibile, inutile, stupida”.
La storia dell’arte è quindi davvero il grimaldello più idoneo a forzare certi episodi apparentemente senza passato, o addirittura oscuri, delle arti visive del Novecento come la Performance Art e la fotografia performativa, legati a strettissimo filo al teatro di regia del Novecento e al cinema. La Performance Art e la fotografia performativa sono sempre, in realtà, espressioni artistiche profondamente dipendenti dalla storia dell’arte e dalle arti dello spettacolo dei secoli precedenti ma più deboli di esse. Spesso gli artisti performativi hanno assorbito la storia dell’arte dai libri, meno dalla visione diretta.
Tuttavia gli artisti performativi che hanno praticato forme di creazione visiva basate prevalentemente sul corpo come materiale principale e sulla resistenza a fatica e dolore come coefficiente di difficoltà, hanno il più delle volte preso decisamente le distanze dalla tradizione e si sono dichiarati museofobici, come se fossero nati come Minerva armati di tutto punto dalla testa di Giove. In realtà, gli artisti operanti o nati nel Novecento hanno fatto spesso ricorso a fonti o modelli non solo del loro tempo, ma anche di età assai più antiche, e la ricerca storico-artistica sa ora cercarne le impronte. Spesso la negazione del legame con la tradizione da parte degli artisti coincide quasi sempre con la negazione anche verbale della tradizione stessa, che si traduce ciclicamente nel concetto della “morte dell’arte” ma quasi mai si esprime in realtà effettiva. La negazione della tradizione coincide anche con il fastidio manifestato dagli artisti per l’inquadramento del loro lavoro nella storia dell’arte e con il conseguente tentativo di allontanare l’attenzione del pubblico dalle fonti delle opere attraverso l’espediente di attribuire a esse titoli semanticamente stranianti che non trovano immediata rispondenza referenziale nell’iconografia/nel tema dell’opera.
Ecco perché alla fine degli anni Ottanta la Performance Art è considerata una forma di arte visiva soprattutto da chi la pratica, da curiosi non particolarmente numerosi, dai sostenitori che si impegnano nella creazione dei nuovi cosiddetti “spazi alternativi” dove fare eseguire le performance (garage e cantine che diventano teatri e gallerie dove non si vende niente, almeno all’inizio). Fuori da questo contesto specifico, fino alla fine degli anni Ottanta la Performance Art è ritenuta genericamente affine ad altre arti performative consolidate, come il teatro, ma ovviamente inferiore a esse. Il metro di giudizio dei critici non è sempre la qualità assoluta di una performance in teatro o in uno spazio alternativo. Il metro di giudizio è spesso tarato sulla vendibilità di ciò che resta di una performance, anche perché, per ragioni strumentali e commerciali, il sistema portante dell’arte contemporanea continua a promuovere prevalentemente l’esibizione e il commercio della pittura e della fotografia.
Gli artisti che dalla fine degli anni Sessanta praticano la Performance art non si pongono davvero problemi lessicali né di genere; anzi, approfittano dell’ambiguità di riferimenti, del non detto e dell’impreparazione del pubblico, confidando nel “critichese” con cui delle performance scrivono i critici che non sono anche storici. Inoltre, per gli artisti performativi (spesso esibizionisti impreparati) il teatro è, nei fatti e insieme anche al cinema, linfa primaria di idee e di parole. Il problema lessicale è, invece, prerogativa dei critici e degli storici.
Nei vent’anni del Novecento durante i quali artisti, pubblico e addetti ai lavori cercano di incasellare la Performance Art, è costante il collegamento del dibattito linguistico e semantico anche all’ambito del dibattito accademico e critico sulle performance teatrali degli attori professionisti. In definitiva, se dalla fine degli anni Settanta la scelta dell’anglismo “performance” permette una rapida comprensione in ambito internazionale del tipo di manifestazione artistica di fronte a cui si trova il pubblico, essa cela anche la sostanziale differenza, di sostanza e di destinazione, tra il teatro e la Performance Art o “arte di comportamento” come si è chiamata fino al giugno 1977, quando a Bologna cambia tutto a cominciare dalla scelta delle parole in una lingua diversa dall’italiano.
Sono proprio gli artisti performativi a ricordarci per primi che senza tradizione (negata, plagiata, rubata, sbeffeggiata, omaggiata) non esiste creazione artistica. Un artista performativo che partecipò alla Settimana internazionale della Performance rispose a un inviato della RAI che gli chiedeva cosa fosse una performance che è il “messaggio di un artista che non ha nulla da dire a un pubblico che non ha nulla da chiedere”. Gli artisti stessi, quindi, sono ironici nei confronti del pubblico al quale si riesce a far credere che un’opera d’arte possa equivalere a una giostra in un parco giochi.
Nel 2016 Lea Vergine, di nuovo in vena di bilanci, di vita e di carriera, ricorda che l’arte è una cosa seria anche quando apparentemente sembra solo un intrattenimento; non è una faccenda per spettatori della domenica, indifferenti, impreparati, che considerano una mostra di arte contemporanea o una performance un’alternativa identica a un giro in centro. Questi spettatori emotivamente imborghesiti pensano per luoghi comuni e gridano a inesistenti scandali per le presunte stranezze degli artisti al cui divismo, però, soggiacciono:
“L’arte non è una religione, né una faccenda per persone perbene. Le cosiddette persone perbene si astengano dal partecipare e dal giudicare, nessuno le obbliga. Ai loro occhi si formano cliché abusati, come il solipsismo di artistoidi considerati tipi bizzarri. L’arte richiede di essere studiata per essere situata, inquadrata. Inutile pensare che il rapporto con l’arte si determini nell’assoluta insipienza” (Lea Vergine, “L’arte non è faccenda di persone perbene”. Conversazione con Chiara Gatti, Milano 2016, p. 75).
Floriana Conte – Professoressa associata di Storia dell’arte a UniFoggia (floriana.conte@unifg.it; Twitter: @FlConte; Instagram: floriana240877) e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia