Con questo titolo, quasi elementare per il sentimento che esprime, sul finire degli anni Ottanta il Manifesto pubblicava un’antologia di poesie e racconti di scrittori palestinesi, cui è seguita l’edizione accresciuta e aggiornata del 2002, con l’Introduzione di Luce d’Eramo.
Superfluo spiegare perché in questi giorni ho ripreso in mano il libro. Il senso d’impotenza che mi pervade di fronte alla tragedia attuale che coinvolge la terra “santa” più profanata al mondo, una terra tanto amata quanto negata, mi porta a scorrere di nuovo queste pagine per cercare di capire meglio, di capire di più, di scavare più in profondità nel sentimento che accomuna i testi della raccolta, pur nella diversità dei modi espressivi o narrativi: l’amore, l’attaccamento disperato e imprescindibile ai luoghi dell’anima, la nostalgia perenne, la condizione di ospite illegale sul proprio suolo, o di appartenente alla diaspora.
Autori diversi, alcuni lontani che vivono in esilio, altri che resistono percependosi come stranieri in patria, ma tutti assimilabili nel grande tema dell’alterità, nella consapevolezza di essere guardati come l’Altro da chi è così vicino a loro e così lontano, altro anche lui.
Non si tratta di affermare la propria identità, non è questo che trasmettono le tante voci palestinesi presenti nella silloge, quanto piuttosto il tentativo di autoesaminarsi per rimuovere da sé la tentazione di negare il diverso, sforzandosi invece di riconoscerlo e ammetterlo.
Mentre rileggo dopo tanti anni liriche struggenti e racconti brevi ma densi di senso, mi dico che si tratta di letterati che hanno una consuetudine con la scrittura letteraria e che solo per questo possono contare su una capacità di sguardo privilegiato, critico e non pregiudizialmente risentito. Una vena patetica, nel senso etimologico del termine, attraversa i loro scritti, anima le parole, dà corpo ai pensieri con una figuralità che non esclude mai i sensi, la carnalità e un’altissima consonanza con la natura. Essere in esilio vuol dire per molti di questi poeti distanza fisica dalla terra, distanza della bocca, della lingua, degli occhi, del naso da quei profumi, da quel mare, da quella terra i cui fiori sono tatuaggi sull’incarnato di giovani donne e che in primavera intarsia i suoi prati con anemoni e narcisi o esplode di nenùferi e altri fiori e il cui maggio è la romanza cantata nell’ombra azzurra degli olivi .
Accenti come questi di Giabra Ibrahim Giabra possono essere ispirati solo da una accesa passione verso la propria terra, spesso assimilata alla figura della fanciulla/donna amata, di un sentimento esclusivo e totalizzante, accentuato proprio da un cocente sentimento, quello dell’esclusione illegittima. Vi si potrebbe scorgere una particolare forma di romanticismo, una sorta di Sehnsucht ( brama, desiderio struggente) e di tensione mistica verso il cielo e le stelle, uno stato di ebbrezza cosmica: Ho eterno sgabello di nubi! dalle cui vette abbraccio ebbro le stelle/ e cammino tra cupole e cime/ m’affaccio al cosmo e vivo/ la lotta che fa giovane l’età (Kamal Nasir).

Ma nelle poesie di molti di questi esuli forzati serpeggiano anche la collera, la rivolta: capire l’altro non è facile, non è naturale, non è spontaneo. Ancora oggi, in piena ripresa violenta della guerra israelo-palestinese, l’invito pressante da parte di osservatori internazionali e commentatori è rivolto al recupero della ragione,alla considerazione di categorie “politiche” come l’utile o l’opportunità di questo esacerbarsi del conflitto: richiami che sembrano però includere la rinuncia alla comprensione reciproca delle ragioni dell’altro, la rinuncia a spegnere l’odio.
L’odio di cui tutti oggi parlano e sparlano. Un odio assurdo, un paradosso storico e un’ombra della memoria ben presente anche nella coscienza dei palestinesi cosiddetti “moderati”, come Rashid Huysan. Odiare forse un popolo/ la cui carne fu cenere/sotto una mano iniqua/.Odiare anche i bambini/- l’età dei miei fratelli-/se hanno un padre che beve/vino sulle mie lacrime?/Pure l’odio al carnefice,/e il perdono ai suoi figli,/sarà,sempre,sarà ancora,/nonostante la miseria? Una brevissima lirica che è un lungo, accorato interrogativo retorico, la cui risposta è No. Il perpetuarsi nel tempo dell’odio come condizione atavica, come catena storica e interiore, come insana eredità trasmessa e da trasmettere? No, risponde il poeta costretto all’esilio, nato in Galilea nel 1936 e morto nel 1980 a New York in un incendio in circostanze mai chiarite.
Altrettanto perentoria però è la sua poesia intitolata Non Voglio nella quale, dopo aver ribadito con la forte anafora iniziale il rifiuto del bambino con la bomba, della sorella con il fucile, dei rami del suo giardino trasformati in forche nella “sua terra” conclude esplodendo: ma dopo il rogo del paese mio/ e dei compagni miei/ e della giovinezza, / come può il canto non farsi fucile? Ancora una volta la risposta è No, non può. La volontà personale schiacciata dalla fatalità dello scontro diventa un fucile che “canta”, cioè poesia civile e lotta politica.
Ecco in tre versi le ragioni della Resistenza, il bisogno di abbracciare la propria causa e di sentirsi tutt’uno con il suolo dal quale si è stati sradicati. Non sono io che piango, ma la terra ( Giabra Ibrahim Giabra). Una terra che è orizzonte profumato[..]terra ove ogni zolla canta gli eroi che vissero e tornano in vita. Vittima ingiusta, patria mia, perché vedo soltanto fronti impolverate? (Abu Salma).
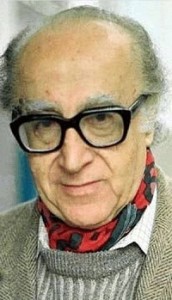
Tra tutte queste voci poetiche, confuso con gli altri come voce tra le tante, c’è quella di Mahmud Darwish, poeta civile universale di tragica attualità, che José Saramago definì “il più grande poeta del mondo”. La profonda vena comunitaria gli ha ispirato versi che non possiamo non sentire congeniali alla nostra sensibilità, laica o cristiana che sia, al nostro sentimento di “occidentali”, distinzione che ormai aborro.
Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri, / non dimenticare il cibo delle colombe. /Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri, / non dimenticare coloro che chiedono la pace./Mentre paghi la bolletta dell’acqua, pensa agli altri/non dimenticare i popoli delle tende./ Mentre dormi contando i pianeti, pensa agli altri, / coloro che non trovano un posto dove dormire./Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri/coloro che hanno perso il diritto di esprimersi./ Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso,/e dì: magari fossi una candela in mezzo al buio.
In un altro toccante componimento, dal titolo Mia madre, il figlio di questa madre-terra di Palestina, eternamente tesa a un impossibile riscatto,elenca con trasporto tutto ciò di cui ha nostalgia, un dolore acuito nei sensi e nei profumi di una cultura avita e di un’infanzia perduta ( il pane, il caffè, il caffè che è un luogo , è geografia, la carezza materna) per poi esprimere il desiderium, la condizione del figlio che da lontano anela a un mondo perduto e il motivo del nostos, tanto caro alla poesia”occidentale”,che qui trova una straordinaria forza di evocazione perché attraversato dalle cose tangibili, dalla concretezza degli oggetti richiamati in vita. Prendimi/ dovessi ritornare,/potessi un giorno tornare/ scialle per la tua frangia,/ copri le mie ossa con erba/fatta pura al tuo passo/legami/ con una ciocca di capelli/ con un filo dell’orlo della veste/ ché io diventi dio.[…]fammi tornare / come tornano gli uccelli/ al nido della tua attesa.
La catastrofe palestinese diventa parola caustica, incisa nei sogni, nell’amore, sui muri della memoria, sul suo corpo di esiliato reso sacro proprio dalla distanza dalla madre-terra. Sacro, per l’appunto, che anche in ebraico ( qadosh) indica ciò che è separato, distante, intoccabile. Anche quando canta l’amore e l’amata Rita ( fantasma poetico), il poeta canta questa distanza, la scissione degli amanti e la scissione dell’io: tra loro, a dividerli lo strumento “diabolico”. Fra Rita e gli occhi miei/ un fucile si leva./ […] Un milione di immagini/un milione di uccelli/ un milione di appuntamenti/ sono stati assassinati/ da un fucile[….] O notte di silenzio! C’era una volta…./ all’alba una luna è calata,/lontano,/ in occhi di miele,/ e la città ha cancellato/e Rita e le canzoni. / Fra Rita e gli occhi miei/ un fucile si leva.
La poesia palestinese è denuncia di chi ha tradito la causa, sofferenza e disperazione, ma alle mie orecchie arriva soprattutto la forma della litania, una trenodia che sa di antico, che fa di tutti questi versi una grande unica preghiera, un unico grande chant d’amour verso il proprio popolo.
E mentre scorrono sotto i miei occhi immagini di orrore e morte, penso, insieme a Darwish che lingua e metafora non fanno una terra , ma continuo a sperare – contrariamente a lui – che la poesia possa cambiare la storia e umanizzare, che la poesia non cambi soltanto il poeta.
Caterina Valchera – Docente, filologa







