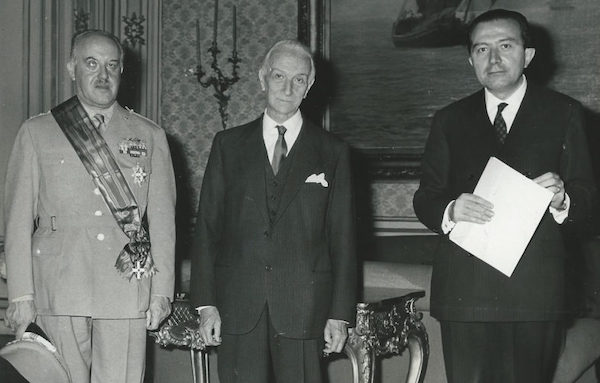Dopo due anni di indicazioni, rassicurazioni e raccomandazioni, la pandemia ha preso un nuovo risvolto sia clinico sia sociale. Non si può dire che sia definitivamente terminata. Il virus c’è, ma la paura è decisamente diminuita. Tuttavia, l’apprensione aumentata, in un lasso di tempo così lungo, ha lasciato il segno nei comportamenti quotidiani di alcuni, a volte anche in modo ossessivo-compulsivo. È chiaramente la conseguenza sociale di un virus che ha sempre continuato – e pare continuerà – a mutare e che, in questo preciso momento, è accompagnato da un altro che sta riempendo gli ospedali: quello influenzale.
Questa volta non si può dire non fosse atteso. I medici lo hanno sempre detto sin da agosto, ovvero dal momento in cui in Australia hanno avuto un’epidemia di influenza. Il problema sul quale ci si basa per eventuali misure è la capienza ridotta delle strutture, con i relativi posti letto che diminuiscono e affollamenti nei pronto soccorso. Come evitare questa saturazione?

Pier Luigi Lopalco
“Lo strumento principe è il vaccino – ci assicura il virologo Pier Luigi Lopalco – e siamo ancora in tempo per farlo. Sappiamo che quelli antinfluenzali sono sicuri, poco costosi e molto efficaci nel prevenire le forme gravi di malattia, che ci portano all’ospedalizzazione. L’Italia ha da anni un sistema vaccinale ben definito anche se le coperture non sono mai soddisfacenti. Nella platea degli anziani – precisa Lopalco – siamo riusciti al massimo a vaccinare poco più del 60% degli aventi diritto. In pratica, la metà degli anziani non si vaccina contro l’influenza. A questi vanno aggiunte tutte le altre categorie che dovrebbero vaccinarsi, come quelle di età più giovane che hanno delle patologie importanti o i bambini. Se riuscissimo ad aumentare i soggetti immunizzati ad ogni stagione influenzale, sicuramente l’impatto sugli ospedali sarebbe minore”.
Ma la domanda fondamentale che a questo punto è lecito farsi è: abbiamo fatto tesoro della nostra esperienza? Sappiamo finalmente muoverci preventivamente per non farci trovare impreparati a nuovi virus? Questa volta si poteva, dato che l’influenza era ampiamente attesa. “Innanzitutto – secondo Lopalco – ci si doveva sbrigare per tempo e con più convinzione per le fasi che servono all’avvio della campagna vaccinale: le gare per l’acquisto dei sieri e i contratti con i medici di medicina generale. Poi, con la campagna informativa di sensibilizzazione”.
Tuttavia, l’aumento della vaccinazione è la prima soluzione, non l’unica. “Banalmente – aggiunge il professor Lopalco – basterebbe che chiunque manifestasse anche qualche lieve sintomo non vada a scuola o a lavoro, o per lo meno si mettesse la mascherina”.
Ma nel quotidiano, basta continuare a indossare le mascherine? Come ha dichiarato il professor Matteo Bassetti, “non possiamo continuare a dare l’obbligo di metterla. Se il Signore ci ha fatto con un naso e una bocca è perché qualcuno li deve vedere. Il problema italiano è stato che il giorno dopo aver detto che non c’era più l’obbligo, qualcuno lo ha interpretato come l’obbligo a non usarle. Nella realtà ci doveva essere una forte raccomandazione per alcune categorie, ovvero fondamentalmente le persone fragili e gli anziani, basandosi sul proprio senso di responsabilità. Con questa nuova influenza lo strumento è uno solo: la vaccinazione”.

Bassetti
Ma quindi, questa mascherina è meglio continuarla a mettere o no? Prima di tutto, con questi due virus che vanno a braccetto, bisogna sempre considerare che l’influenza colpisce prevalentemente i più piccoli, mentre per il Covid, le persone più ad alto rischio rimangono gli anziani. Per queste due categorie, dunque, l’uso della mascherina è altamente raccomandato nei luoghi chiusi. Fermo restando che con una dose di richiamo per il covid e una anti-influenzale, qualsiasi virus si riduce, nella stragrande maggioranza dei casi, a poco più di un raffreddore.
Ma ciò che fa specie, se non altro per la fatica a trovarne senso logico, è vedere per strada ragazzi più o meno giovani indossare la mascherina FFP2. Molto più, se pensiamo ad alcuni che addirittura la usano correndo o in palestra durante l’esercizio fisico, con il rischio di un collasso. Più in generale, sono ancora parecchie le persone che continuano a indossarla all’aria aperta, nonostante sia acclarato che sia quasi impossibile contrarre il virus in tali condizioni: solo una persona su mille, infatti, si infetta fuori dagli ambienti chiusi. Lo conferma uno studio irlandese. A cosa dobbiamo quindi queste tendenze?
Gli aspetti psicologici del virus, ma soprattutto dell’isolamento sociale che abbiamo vissuto, sono sicuramente i sintomi più nascosti ma infimi allo stesso tempo e per nulla da sottovalutare. L’ipocondria è un disturbo psichico acclarato e in questi due anni, secondo gli esperti della Società Italiana di Psichiatria (Sip) si è generata una nuova forma di ipocondria da Covid che rende le persone molto più sensibili. La domanda di terapia è infatti aumentata alle stelle durante la pandemia e gli esperti hanno da tempo previsto il profilarsi all’orizzonte di una crisi di salute mentale.
In particolare, sono già un milione in più, con un aumento di almeno il 30% dall’avvento del Covid-19, i pazienti presi in carico dal Sistema sanitario nazionale per salute mentale: un altro effetto sostanziale che il virus ha inflitto alla nostra società. Se infatti l’1,5% degli italiani usufruisce dei servizi di salute mentale, pari a circa 900 mila, c’è un altro 5% (quasi 4,5 milioni) che si stima ne abbia bisogno ma non riesca ad accedere alle cure.
Nel complesso, la “sindemia” (ovvero l’insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici) ha portato con sé circa un milione di nuovi casi di disagio mentale. Per la Società Italiana di Psichiatria serve un aumento di budget pari a tre miliardi per ovviare al problema e ridare benzina ai dipartimenti di salute mentale, aumentare i servizi e coprire la richiesta crescente dei cittadini in ogni fascia d’età.
In questo caso, i soggetti a più alto rischio risultano essere i giovani, le donne e gli anziani, mentre le cause più comuni sono le ripercussioni sociali e lavorative, il modificarsi delle relazioni sociali, la solitudine e la depressione. I modi base per affrontare questo malessere possono essere diversi: fermarsi e respirare, riflettere, connettersi con gli altri, conservare abitudini sane, rispettare se stessi e gli altri.
È dunque più che plausibile – e anche socialmente molto prevedibile – che parecchia gente sia rimasta psicologicamente traumatizzata dalla pandemia e che ora faccia parecchia fatica a “tranquillizzarsi”.
Non si deve ignorare che esiste assistenza e non bisogna rifiutarsi di richiederla. Molti pazienti fanno fatica a riconoscere il peso specifico dei propri turbamenti. Se si provano misure per alleviare lo stress, ma ansia, tristezza o rabbia persistono tanto da influenzare parti importanti della propria vita, potrebbe essere il momento di cercare aiuto.
In Italia esistono associazioni di promozione sociale e orientamento verso un percorso di cura. Ci raccontano di un sostanziale aumento di utenza, registrato dall’inizio della pandemia: “Le richieste sono aumentate e soprattutto sono aumentate le persone che ci vengono a chiedere aiuto dicendo che è proprio da quando è iniziata la pandemia che hanno iniziato ad avvertire sintomi di disturbo alimentare oppure che sintomi pregressi sono peggiorati nettamente” afferma la vicepresidente del centro “Libenter” di Torino, Melissa Panero.
“Le paure che abbiamo notato aumentare sono quelle ad ammalarsi, maggiore angoscia, stress, e l’acutizzarsi di problematiche precedenti che prima del covid erano compensate – racconta invece la dottoressa Luigina Pugno, psicoterapeuta dell’associazione Eco – Anche sentire della rianimazione o delle persone decedute per il virus ha riportato a galla, ad esempio, i lutti personali che non erano stati elaborati. Ultimamente, invece, c’è un po’ più di preoccupazione per il futuro lavorativo” aggiunge la dottoressa.
È difficile innanzitutto riconoscere dunque un proprio disturbo, ma il passo successivo, più problematico, è quello di rivolgersi a un professionista. Sono ancora tanti, infatti, coloro che si trattengono dal chiedere aiuto per la paura di essere etichettati socialmente, pur avvertendo molto malessere: come spingerli a cercare una cura?
“Ciò che deve fare da campanello d’allarme – avverte la dottoressa Pugno – è il prolungarsi nel tempo della difficoltà emotiva che si sente, oltre che un’intensità importante, perché vuol dire che la nostra mente non sta riuscendo a elaborare quelle situazioni che hanno creato una sofferenza e se le trascina”.
“La cultura che ce la si debba fare da soli, rende la gente restia – evidenzia invece Panero – andare dallo psicologo è ancora considerato un tabù, invece è importante, oltre al coraggio, avere proprio l’umiltà di chiedere aiuto, anche solo a un genitore o amico: è importante fare molta prevenzione e promozione sociale per far arrivare il messaggio che non è una forma di debolezza, anzi”.
Il problema potrebbe avere anche delle sostanziali differenze fra generazioni o classi sociali. I boomers (dai 55 ai 75 anni), ad esempio, potrebbero avere meno probabilità di cercare servizi di salute mentale rispetto ai millennials (dai 23 ai 38) o alla generazione (fino ai 22), visto che la maggior parte non ha più un genitore con cui confidarsi.
In conclusione, c’è da stare attenti a mantenere un equilibrio. Vaccinazione sempre e a prescindere, la mascherina come accorgimento in più nei luoghi chiusi e affollati, ma occhio a non esagerare: si potrebbe sfociare in qualcosa di più grave.
Enrico Scoccimarro – Giornalista praticante