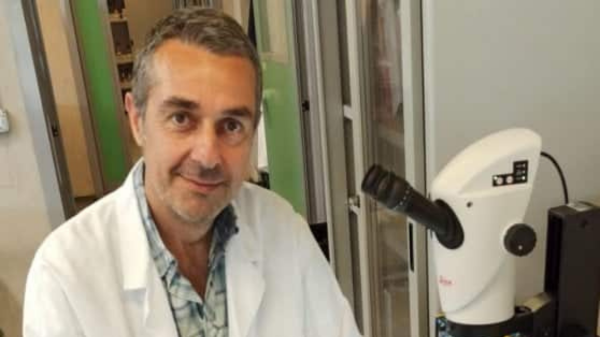Ah la scuola croce e delizia di studenti e insegnanti. “Croce e delizia” mi piace, non so se l’ho inventata io ma è una espressione che rende l’idea. In effetti più croce che delizia, almeno a stare ai programmi imposti dal Ministero a quei poveri ragazzi. Anzi, a quelle povere ragazze, (basta con i riferimenti maschilisti!), obbligate a sorbirsi tediosi polpettoni che parlano di cose lontane, complicate e ormai incomprensibili. Sulle materie scientifiche non mi pronuncio, perché non ho le competenze sufficienti (a proposito, ma “sufficenti” senza la “i”, come “celo” o, appunto, “scentifico”, non sarebbe meglio? Chi, a parte qualche meridionale inveterato, quando parla fa sentire quella vocale fantasma?
Perché mettere tanta inutile distanza tra la lingua viva, parlata, e quella scritta e paludata? E quando un(a) parlante dice “azione” sembra sempre di sentire il raddoppiamento di quella “z”, a meno che, al solito, non sia un(a) oriunda(o) del Sud; dunque si dovrebbe almeno consentire di scegliere a piacere se usare una o due zeta); dicevo che non parlo di matematica e affini, ma sugli argomenti letterari penso proprio di poter dire la mia. Qualche decina di milioni di copie vendute mi daranno pure il diritto di esprimermi in modo definitivo!
No come quel pallone gonfiato di Harold Bloom, autore di un libro/mattone che nel titolo italiano si può confondere con un trattato di cinofilia sull’Alano, il San Bernardo, il Pastore dei Pirenei, il Mastino napoletano e altre razze grandi taglie, prima che ci si renda conto (ma per questo bisogna leggerlo, cosa che hanno fatto in pochi) che il riferimento non è al cane gigantesco, una specie di Ur-molossoide, ma al cànone, con l’accento sdrucciolo. Soliti snobismi lessicali ad uso di pochi eletti.

Harold Bloom
Insomma, questo professore, ritenuto (chissà perché!) uno dei più influenti critici letterari di tutti i tempi e di (quasi) tutti i luoghi, si è permesso di non citare il mio nome. Mai, neanche un capitolo mi ha dedicato; ma che dico un capitolo, un paragrafo, un inciso, una parentesi, una mezza parola. Niente, nulla, nihil. Come uno Stefano D’Arrigo, un Giorgio Manganelli, una Dacia Maraini qualsiasi.
E pensare che nel suo Canone Occidentale Bloom, quando parla degli autori italiani del Novecento, cita questi nomi: Luigi Pirandello, Gabriele D’Annunzio, Dino Campana, Umberto Saba, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Tommaso Landolfi, Leonardo Sciascia, Pier Paolo Pasolini, Cesare Pavese, Primo Levi, Italo Svevo, Giorgio Bassani, Natalia Ginzburg, Elio Vittorini, Alberto Moravia, Andrea Zanzotto, Italo Calvino, Antonio Porta. Di Susanna Tamaro zero, neanche l’odore.
Ma la cosa più incredibile è che al culmine della sua piramide il professore, che ha una concezione chiaramente verticistica della letteratura, ha pensato bene di piazzare due autori vecchi, vetusti, antichi e, diciamolo pure, obsoleti: William Shakespeare e Dante Alighieri. Praticamente “Anticaja e Petrella” direbbe una mia amica di Roma, alla quale ogni tanto scappa qualche buffa espressione nel dialetto capitolino. Mentre a me Shakespeare interessa relativamente (visto che appartiene a una cultura che non mi tocca da vicino), che subito dopo venga quel barbogio di Dante sinceramente mi dispiace e mi preoccupa. Non tanto per me, quanto per le/i giovani che studiano; che invece di essere attirate/i verso la lettura di opere moderne, che presentano tematiche attuali e interessanti, devono sorbirsi storie di notabili e ottimati oggi sconosciuti, dei quali, anche quando si leggono le spiegazioni nelle note, in genere non si capisce un’acca o, se qualcosa si riesce ad afferrare, si conferma come estranea agli interessi dei giovani lettori.

Dante

Shakespeare
Io, che non ho peli sulla lingua, questo l’ho detto chiaro e tondo un po’ di giorni fa a Torino durante il Salone del libro. Basta con le ipocrisie. Assieme a uno studioso di vaglia come Flavio Troisi – che peraltro, tengo a precisare, non è neanche un estimatore della mia opera (nessuno è perfetto) – abbiamo varie idiosincrasie in comune: Alessandro Manzoni, cattolico santimonioso che razzolava molto meno bene di come predicasse, cui io aggiungo quel gobbo pessimista e senzadio di Giacomo Leopardi.

Giovanni Verga
Ma soprattutto io ho per un autore un’avversione insuperabile, del tutto condivisa con Troisi: Giovanni Verga. Che accomuno per antipatia a Sibilla Aleramo, di cui faccio mia la definizione che ne diede Giuseppe Prezzolini, “lavatoio sessuale della cultura italiana”. Io a Bloom le avrei anche cantate come il mio Dio comanda, ma mi sono accorta che è morto da più di tre anni. Per farlo avrei dovuto ricorrere a una séance, come un tempo gli esoteristi chiamavano la seduta spiritica, ma non l’ho fatto per coerenza e per non essere confusa con la Aleramo e i medium suoi accoliti.
******
Bene! Sin qui i miei milioni di lettori (che volete farci, ormai sono entrato nell’orbita dei grandi numeri) perdoneranno il tono paradossale e parodistico, dettatomi dalla voglia di celiare sotto le false (ma non mentite) spoglie della sig.na Tamaro su qualcosa che, a mio avviso, o lo si prende così oppure lo si affronta con il rigore e l’acribia dei critici di professione; i quali di scherzare su personaggi del genere e le loro asserzioni non hanno, comprensibilmente, alcuna voglia. Eccetto qualche sparuto carneade, che pensando di avere anche lui/lei una piccola quota di notorietà ne ha preso le difese, si contano a decine le reazioni negative, molte anche feroci, alle sue affermazioni sulla scuola e sui programmi delle materie umanistiche.
Adesso, smetto anche io il mio giochetto e parlo, anzi cito, per davvero. Con una premessa, per non sembrare maramaldesco, su una condizione clinica di cui la stessa interessata ha parlato e parla senza farne mistero. Per esempio, da un suo articolo (a mo’ di autorecensione del libro “Il tuo sguardo illumina il mondo”, pubblicato nel 2018) dal Corriere della Sera è tratta questa frase: “Soffro della sindrome di Asperger, è questa la mia invisibile sedia a rotelle, la prigione in cui vivo da quando ho memoria di me stessa. La mia testa non è molto diversa da una vecchia motocicletta”. Dal “ Sole 24 ore” viene quest’altra informazione sul carattere autistico della sua condizione, “caratterizzata da difficoltà nell’interazione sociale e da modalità di comportamento e interessi inusuali e ripetitivi”, con la tendenza a parlare per frasi fatte, accompagnandole con una gestualità che può essere stereotipata, pur senza deficit nella sfera critico-cognitiva. “Fu il pediatra austriaco Hans Asperger a circoscriverne la fenomenologia (…). Il termine autismo oggi è stato sostituito con autismi, al plurale, o con il concetto più ampio di spettro autistico”.
Al Salone del Libro del mese scorso, dunque, non sempre senza qualche sgangheratezza sintattico-testuale, ipsa dixit: “La scuola dovrebbe fare urgentemente alcune cose: la prima togliere quelle inutili farraginosità che impongono [vengono imposte, n.d.r.] fino dalle scuole primarie, tipo l’analisi del testo. Un testo va goduto in sé senza nessun tipo di interpretazione intellettuale. Almeno [a meno, n.d.r.] che uno non desideri studiare Lettere all’università, va fatto vedere che c’è un piacere di leggere che è puro, che non richiede interpretazione, cose come ‘Va’ dove ti porta il cuore’ [allusione, verosimilmente scherzosa, al proprio celebre best seller, n.d.r.] (…). La scuola ti disgusta [ti fa disgustare, n.d.r.] alla letteratura, la odi [odii, n.d.r.] ferocemente, odi [odii, n.d.r.] fare Dante, cose difficilissime che già alla mia età [forse intendeva dire ‘epoca´, non ‘età’, n.d.r.] erano incomprensibili. Io ho odiato leggere da bambina, capisco perfettamente (…).

Salone del Libro
Non si può imporre a un ragazzo alle superiori di leggere Sibilla Aleramo e Giovanni Verga senza provocare un assoluto odio per la lettura. Io stessa il Verga l’ho studiato 50 anni fa e l’ho detestato. (…) un ragazzo per farlo appassionare [perché si appassioni, n.d.r.] deve leggere cose che lo riguardano, anche libri semplici, di consumo, purché sia qualcosa che lo tiene attaccato alla pagina. Ti piace il calcio, leggiti la vita di un calciatore, le memorie di Totti; cominciamo così, dopo si va avanti. Ma cominciare con Verga, con Sibilla Aleramo (…) è il modo migliore per chiudere questa possibilità di lettura nella vita adulta”.

Susanna Tamaro
Ma la coerenza, evidentemente, o non appartiene a Susanna Tamaro o lei non la ricerca, se appena tre anni fa, nel 2019, parlando di un altro suo libro, “Alzare lo sguardo, il diritto di crescere, il dovere di educare” se la prende con la permissività nell’educazione. “Nel Paese dei balocchi in cui viviamo risuona un unico imperativo, ‘Lascia perdere!`. La memoria e il rigore, l’impegno e l’etica sono fatiche inutili (…)”. “Si cresce, cioè si diventa uomini liberi, ci si conosce, e si conosce se qualcuno ti insegna. Magari senza troppi sussidi e concessioni alle pedagogie dominanti. Un maestro, che sappia tirar fuori il meglio di noi, che ci insegni anzitutto a farci delle domande”.
In una rara lettera da lettore qualificato, in cui non si liquida “in blocco” la Tamaro “tranciatrice” di giudizi sui programmi letterari, un docente di scuola superiore, evidentemente ben fornito di fairplay (dote che si auspicherebbe fosse recepita e imitata anche dai suoi alunni) concede che “sarebbe fin troppo facile chiudere il discorso affermando che la Tamaro sta a Verga come Alvaro Vitali sta a Orson Welles”. “Sicuramente – aggiunge l’insegnante – il programma di letteratura nel triennio è debordante ma, se alcuni ridimensionamenti si impongono per necessità di sopravvivenza di alunni e docenti, sarebbe bene orientarsi su autori più lontani, come Poliziano, Guicciardini, Tasso, Alfieri…”.
Ma riguardo all’autore dei Malavoglia non ha dubbi: “Arriverei anche fino a mettere in discussione Carducci, ma Verga proprio no!! (…) Negli scorsi anni ’70 il grande linguista Tullio De Mauro fece una ricerca che dimostrò la padronanza lessicale di circa 1500 parole per gli studenti del biennio superiore; negli anni 2000 la stessa ricerca ha rivelato una vertiginosa caduta a 400 termini. Penso che le cause siano molteplici: non vorrei formulare ipotesi azzardate, ma non credo che siano da ascriversi a Verga”, chiude con un understatement amaramente ironico. Chissà che letture come certe autobiografie di calciatori, auspicate dalla Tamaro, non farebbero precipitare ancora di più quei numeri già così scoraggianti. Certo, trattenere l’ironia di fronte a certe prese di posizione può essere un’impresa ardua. Con battute più o meno felici io avrei potuto continuare. Se si parla di pallone perché no di altri sport popolari; ed ecco che il verghiano Ciclo dei Vinti è la bicicletta di chi per un soffio vede sfumare la “maglia rosa” al Giro. Oppure si potrebbero fare battute anatomiche: “Va’ dove ti scoppia il fegato” (o altri organi, a piacere) se il libro più venduto della Nostra lo leggi pure; e ciò in ultima analisi conferma che il genere preferito dal grosso pubblico (dalle scarpe sottilissime, si badi bene…) è il romanzo d’appendice o, meglio, d’appendicite, se dopo averlo comprato ne intraprendi anche la lettura.
Preferisco però ricordare la presa di posizione, giustamente indignata, del Consiglio Scientifico della Fondazione Verga dopo le parole oltraggiose e ridicole della scrittrice. All’autrice del maggior best-seller dell’editoria italiana la Fondazione catanese risponde indirettamente, ricordando, fra altre cose, che la logica del mercato del libro, e dei suoi interessi economici, non può pensare di imporre senza alcun ritegno le sue scelte al canone letterario del nostro Paese; che l’insegnamento della letteratura a scuola, pur adeguandolo ai tempi, non può rinunciare ai grandi classici e alle domande di senso che da essi possono scaturire; che le letture “amene”, come il libro più famoso della signora Tamaro, possono far evadere dalla cruda realtà, ma non forniscono ai ragazzi quella sensazione di rispecchiamento che gli psicologi additano come passaggio fondamentale per la crescita dell’io.
E allora, conclude la Fondazione, è più formativo per mettere in guardia dal bullismo il “brutto e cattivo” Rosso Malpelo o la letteratura alla melassa?
Troppo presa, forse, dal proprio dramma personale, la Tamaro cerca di sublimare il suo essere una “Aspie” (così si chiama chi è affetto dalla sindrome di Asperger) attraverso la scrittura. Ma lo fa riproponendo, come in un gioco di specchi, sempre gli stessi temi in una specie di mélo senza musica, che alla fine scade nella melensaggine, in una riedizione tardiva di quello che è stato definito “neorealismo d’appendice”.
Non va mai, nel suo buonismo di prammatica, oltre i confini di chi fa “la cosa giusta” verso i poveri sofferenti, specialmente se soffrono del suo stesso male, che da oscuro si è fatto conclamato ed evidente. Non ha pulsioni empatiche verso chi è venuto dopo di lei e ha affrontato la grande crisi generazionale che a ondate si riverbera ancora oggi, amplificata dai guasti e dalle incognite del mondo globale. Per lei la “generazione di mezzo” post-sessantottina è un’accolita di “scoppiati”, di suicidi, di senzadio. Il suo pensiero non è né forte né debole, né epico né minimalista. Qualcuno l’ha definito “reazionario” tout-court. Se poi ha venduto a milioni come Manzoni, come Dostoevskij, come Hemingway buon per lei; era già, come si suol dire, ricca di famiglia ed è solo piovuto sul bagnato. A noi ben poco cale.

Manzoni
I mercanti della carta seguiteranno, sin che potranno, a impinguare le loro casse e ovviamente i proventi dell’autrice con quella che in portoghese si chiama “literatura de cordel”, sinonimo di scarsa qualità. Opere, soprattutto di poesia, che si leggono in mezz’ora e che in Brasile di solito sono stampate su libricini le cui pagine sono tenute insieme da un cordoncino. In Portogallo, a metà del XX secolo, erano riservate quasi esclusivamente ai testi di fado. Bloom, per questo genere di produzioni, ha parlato di “letteratura da supermercato”.
Ragionando sulle opere della Tamaro, un’altra autrice che emerge dai recessi ormai sbiaditi della memoria, nonché dai racconti di madri e nonne del Novecento, non può che essere la comasca Liala, che ha lasciato oltre ottanta volumi pubblicati, oltre a poesie e carteggi inediti. Rispetto alla regina del “romanzo rosa” e “d’evasione”, che pur suscitando l’ironia della critica non ne era affatto scevra lei stessa nelle sue trame, La Tamaro, triestina, ne è una specie di versione “strappacore”. Però l’ironia e non di rado il sarcasmo che la riguardano è solo quello riservatole dai critici.
Pur vantando un’ascendenza (da parte materna) con Italo Svevo, evidentemente deve aver smarrito i geni familiari. Del “witz”, il famoso spirito ebraico immortalato da migliaia di testi e storie soprattutto di origine sefardita, nei suoi libri non v’è praticamente traccia. Un altro elemento mitteleuropeo ebraico di cui invece risulta abbondantemente provvista è la “chutzpah”, termine yiddish che indica un atteggiamento tra lo sfrontato e l’arrogante. Ne ha dato prova, per esempio, dopo le quasi unanimi stroncature seguite all’uscita del suo libro più famoso, quando per rintuzzare quei giudizi negativi ha sostenuto che i partiti la corteggiavano perché era in grado di spostare milioni di voti e che era stata colpita dall’ostracismo della sinistra in quanto anticomunista e perché segue la morale tradizionale cattolica. In effetti, si può avere molta “chutzpah” anche senza essere ebrei.
Carlo Giacobbe – Giornalista, scrittore