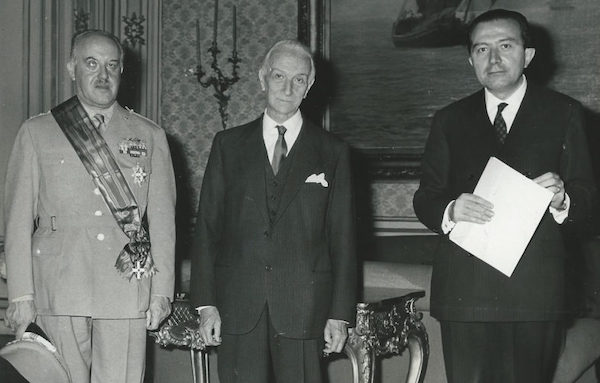“Io ho la gioia di credere e penso che la vera nascita sia la morte. Noi siciliani abbiamo il culto della morte. Il siciliano è vestito di nero perché attende la morte, cioè la sua vera vita”. Parole di Agostino La Lomia, duca di Giantonina e barone di Renda, Carbuscia e Torrazzo, campione di eccentricità e di stravaganza nella Sicilia del secolo scorso.

Uno che con la morte aveva una singolare, affabile confidenza al punto di inaugurare ufficialmente la sua tomba, lui ancora in vita (si era nel 1967 e aveva sessantadue anni), dinanzi alla quale si fece fotografare, naturalmente sorridente, nel corso di un festoso conviviale con rinfresco a base di mandorle e pane, come nella tradizione contadina, conditi da vino rosso.
Ci teneva molto, il barone La Lomia, a una residenza funebre di lusso perché soleva dire che “la vera casa è la tomba: bisogna pensare alla morte quando si è in letizia”. In realtà, il barone La Lomia di dimore per l’aldilà ne pretendeva due: una nella chiesa Madre, l’altra nel cimitero, una in città, l’altra in campagna per la villeggiatura. Non fu accontentato: quella presso la chiesa Madre gli fu negata e si dovette accontentare del solo loculo in terra al cimitero.
In compenso però dettò, con dovizia di particolari, le condizioni del suo funerale, che doveva essere solenne e gaio. Per l’occasione si era fatto costruire una lussuosa bara di legno d’olmo grazie al lascito della madre di 787 sterline. Le sue volontà disponevano che la Berlina funebre sarebbe dovuta essere trainata da cavalli bianchi, seguita da almeno quattrocento invitati (in primo piano preti, monache, orfani, accattoni) e da due bande musicali, quelle di Acireale e di Canicattì, chiamate ad esibirsi in un vasto repertorio di marce.
Agli invitati non residenti sarebbe stato garantito un congruo rimborso per le spese del viaggio. A tutti sarebbero stati offerti a iosa gelati e cassate. Alle operazioni di seppellimento avrebbero dovuto sovrintendere una ventina di becchini internazionali, primo tra tutti il becchino del “cimitero della felicità” di Lisbona, e tra di essi un notaio dalla mano adunca, un ingegnere con un piccone demolitore, un deputato democristiano con una forchetta, un banchiere con un nodo scorsoio. Come per Pirandello, il suo cadavere sarebbe dovuto essere seppellito nudo, con accanto però quaranta sacchi di terra a ricordo dei suoi feudi. Naturalmente il barone ebbe la premura di predisporre e diramare personalmente gli inviti per lo straordinario evento, accollando ai destinatari l’onere di aggiungere a mano la data del trapasso.
Non ci è dato sapere se il barone La Lomia avesse preparato il testo del suo necrologio da far pubblicare sulla stampa. Ma è molto probabile che lo avesse vergato con eleganza calligrafica se si pensa a quello che uscì sul Giornale di Sicilia nell’estate del 1965 per la dipartita del suo inseparabile amico Annarino: “Investito da mano pirata è deceduto tragicamente il 5 agosto 1969 a Canicattì S.E. il Referendario Paolo Annarino e Gatto. Ne dà il triste annunzio don Turiddu Capra, duca di Santa Flavia e Merlo, che lo ebbe padre, fratello e amico. I resti mortali saranno tumulati di fronte al mare Ionio nell’isola di Capo La Croce in quel di Taormina”. Annarino era il suo gatto e don Turiddu Capra il suo merlo. È superfluo ricordare che Annarino, così chiamato per il suo irrequieto girovagare, godette, come annunciato nel necrologio, di dignitosissimo funerale.
Il fatto che il barone La Lomia fosse ossessionato dalla morte non deve far pensare a un tipo cupo. Tutt’altro: era quel che si dice un viveur, un gaudente. Amava la vita mondana, era sempre presente alle più importanti rassegne cinematografiche: alla Mostra del Cinema di Venezia e al Festival di Taormina sfoggiava il suo elegante e vistoso look con la sua corporatura possente e la barba fluente e curata, i capelli annodati in un codino precursore di tendenze della moda ancora a venire. Ed era anche un impenitente tombeur de femmes, anche se dopo ogni amplesso si segnava la fronte (“il segno della croce lo faccio sempre – diceva – anche quando una donna mi onora”).
In lui Thanatos ed Eros convivevano senza apparente dissidio. Sapeva assaporare le delizie della vita con più di un pizzico di leggera follia e con una filosofia tutta sua; amava ripetere: “Tutto nella vita è sciocchezza più o meno importante”. Né la sua anima era priva di religiosità, del tutto personale ovviamente. Si dichiarava credente ed era orgoglioso del suo titolo di abate laico. D’altra parte era nipote del Venerabile Cappuccino padre Gioacchino La Lomia e, per ironia della sorte, era nato nello stesso anno, 1905 a Canicattì, in cui morì il missionario in odore di santità. Così diverse le loro esistenze: quella del cappuccino vissuta da povero tra i poveri, quella del barone nell’allegra dissolutezza.
Cristiano a modo suo, Agostino La Lomia compariva regolarmente a messa ogni domenica portando con sé una sedia personale che andava a piazzare al centro della chiesa di San Domenico a Canicattì ed era legato da genuina amicizia col suo parroco, padre Meli. L’affettuosa familiarità con padre Meli, appassionato di tradizioni locali e autore di diverse pubblicazioni, il suo don Pirrone, è testimoniata dal fatto che il barone insignì il religioso del titolo di “arcade minore” dell’Accademia del Parnaso.

Già, l’Accademia del Parnaso, una geniale trovata rivelatrice dello spirito burlone di Agostino La Lomia. Il barone la fondò da giovane, nel 1922, nella sua Canicattì. Ebbe uno statuto e i suoi soci, quasi fosse un’istituzione seria, quando invece costituiva la divertita espressione di una goliardica e irriverente presa per i fondelli di tutto ciò che induceva all’ufficialità, alla pomposità, all’alterigia in un’epoca, quella mussoliniana, in cui ridere, per l’enfasi e la ridondante retorica del regime, tanto era spontaneo quanto sospetto agli occhi dei gerarchi.
L’Accademia del Parnaso ebbe i natali in una taverna di Canicattì (sebbene si attribuisse origini storiche risalenti ai tempi di Carlo V) e riunì un gruppo di buontemponi “buoni a nulla e capaci di tutto” (per dirla con Longanesi), capaci soprattutto di confezionare estrose turlupinature ancora degne di memoria. Le beffe degli Amici miei del film di Monicelli impallidiscono dinanzi a quelle messe in atto dai membri dell’accademia.
Era composta dagli “arcadi maggiori” e dagli “arcadi minori”, tutti “poeti”. All’articolo 7 dello statuto si stabiliva, infatti, chi ne poteva fare parte: “Chiunque, anche senza il fine di nuocere, abbia fatto poesia, è iscritto al Parnaso d’ufficio o a sua confessione”. Ma chi poteva considerarsi poeta? Lo statuto lo precisava fugando ogni dubbio: “Chiunque, pur avendo superato la minore età, crede ancora all’eterno amore e alla fedeltà delle donne: poeta! Chiunque voglia rigenerare, moralizzare la vita pubblica e privata degli uomini e raddrizzare le gambe ai cani: poeta! Chiunque, non pago di avere ragione pretenda, per di più, di vincere una lite: poeta! Chiunque creda al ritorno dall’aldilà o al recupero di oggetti smarriti: poeta! Chiunque, avendo preso in prestito del denaro, si illude di poterlo restituire: poeta!”.
Come detto, all’interno del Parnaso vi erano gli “arcadi maggiori” e gli “arcadi minori”. Ma nella categoria dei “maggiori” venivano inclusi, oltre ai poeti locali, gli analfabeti, gli imbecilli, i matti del paese; in quella dei “minori” figuravano, a loro insaputa, letterati illustri quali Pirandello, Marinetti, Bontempelli. D’altra parte lo statuto (articolo 2) recitava al riguardo: “Sono maggiori i non minori e viceversa, perché le cariche si attribuiscono a ritroso”. Ad essere insignito del titolo di “arcade maggiore” fu, nel 1926, un prefetto, fedelissimo al regime, che, giunto ad Agrigento, dichiarò che avrebbe raddrizzato le gambe ai cani. Il che lo faceva rientrare di diritto, stando alla lettera dello statuto, tra i poeti. Il prefetto, in un primo momento, si sentì gratificato dal titolo ricevuto, ma poi, scoperto che tra gli “arcadi maggiori” trovavano posto i fessi, minacciò di fare chiudere l’accademia ricordando che “con certe cose non si scherza”.
Come ogni sodalizio che si rispetti, anche il Parnaso aveva un’effigie quale emblema, un logo, si direbbe oggi; ed era, all’origine, un’asina alata: “Emblema dell’Accademia è un’asina alata. Essa è immortale, casta e pura, e sarà sempre presente a tutte le riunioni assembleari” (articolo 3 dello statuto). Successivamente, nel 1925, a suggellare l’accresciuta importanza dell’accademia, si decise di affiancare all’asina alata un leone. Ma il tipografo di Canicattì non aveva la stampa del leone e i parnasiani si recarono a Palermo in cerca dello stemma del leone. Trovarono, però, immediatamente disponibile quello del cane. Agostino La Lomia e company, spinti dalla fretta, si accontentarono del cane, che divenne, accanto all’asina alata, il “marchio” dell’accademia, con una postilla: “Questo cane è un leone, a norma del decreto 34256 del 2 luglio 1925”.
Del Parnaso Agostino La Lomia non fu il presidente, ma il vicario. La più alta carica spettò, invece, all’oste Ciccio Giordano, l’unico dei soci ad essere iscritto al Partito Nazionale Fascista. La sua presidenza si consolidò post mortem. Successe, infatti, che ai funerali di Giordano, nel 1930, si richiamò il suo nome, come in ogni onoranza funebre fascista, risuonando quell’invocazione rituale come un appello: “Camerata Francesco Giordano…”. I soci del Parnaso risposero in coro: “Presente!” e due arcadi minori commentarono: “Se il presidente, da morto, risponde ‘presente’ è segno che non è morto: dunque è immortale”. Fu così che Ciccio Giordano fu consacrato in saecula saeculorum presidente dell’Accademia del Parnaso.
Quando nel 1929 nasceva la Reale Accademia d’Italia, presidente il già ministro degli Esteri Tommaso Tittoni ai tempi di Giolitti, la prestigiosa istituzione ricevette un telegramma dal Parnaso: “Questa secolare Accademia saluta giovane consorella”. Solerte fu la risposta firmata da Tittoni (tra Accademie era buona creanza intrattenere relazioni solidali…): “Accademia d’Italia saluta illustre e antica consorella di Canicattì”. Poi però, quando si scoprì quanto scalmanata e beffarda fosse la “consorella” siciliana, Agostino La Lomia e il suo Parnaso rischiarono l’accusa di antifascismo. Accusa, invero, non infondata perché l’esercizio della beffa contro le autorità e il ridicolizzare la magniloquenza dell’apparato del regime costituiva, a suo modo, una manifestazione di avversione al fascismo.
A proposito, quale esempio della sfrontatezza del Parnaso, resta memorabile questa epigrafe affissa alla statua di Pinco Pallino, proclamato eroe dell’associazione: “La patria riconoscente / a Pinco Pallino, / Ch’essendo buono a nulla / nulla (oh benedetto!) / fece. / Esempio perenne / e monito urgente / agli altri grandi uomini”.
Tuttavia, malgrado gli sberleffi della sua accademia, Agostino La Lomia riuscì a cavarsela durante il fascismo; in un modo o in un altro le sue impertinenze, non gradite dal regime, furono coperte e, quel che più gli interessava, i suoi possedimenti non furono toccati. Le cose, per il barone, peggiorarono nel dopoguerra e, soprattutto, con la riforma agraria che aggredì parte dei suoi averi. Possedeva abbastanza, Agostino La Lomia, tra terreni e palazzi anche di prestigio, non solo a Canicattì, ma anche a Palermo e a Taormina e in altri luoghi dell’isola. Avrebbe potuto continuare a condurre una vita agiata anche dopo la riforma agraria se avesse avuto un minimo di capacità imprenditoriale. Non l’aveva e sapeva solo dilapidare in divertimenti mondani e in scelte amministrative sbagliate il suo patrimonio.
Fu proprio una dissennata vicenda legata alla vendita forzata di un antico palazzo di famiglia a Palermo, nei pressi del Politeama, costruito su progetto di Tommaso Aloisio Juvara, a segnare l’accentuarsi della parabola discendente di Agostino La Lomia. In quella ottocentesca dimora La Lomia trascorreva lunghi periodi condividendo le spensieratezze dell’aristocrazia palermitana. Secondo alcune fonti, quando soggiornava a Palermo, seguendo il vezzo di altri nobili dissipatori dei propri averi, paladini di bislaccheria, godeva anche di una suite riservata all’Hotel delle Palme. L’atto di vendita del centralissimo palazzo palermitano fu firmato il 5 ottobre del 1961.
Dopo quella disavventura amministrativa, La Lomia si ritirò a Canicattì nel suo palazzo di via Cattaneo ricevendo pochi amici, tra i quali padre Meli (che gli fu sempre vicino), e alternando alti e bassi umorali. Non mancarono i momenti di chiassosa euforia e di eccentrico protagonismo, come testimoniano la ricordata inaugurazione della sua tomba e le interviste concesse ai giornalisti cui faceva gola la sua personalità bizzarra e il suo “filosofare” ardito.
Ma la leggerezza dei tempi del Parnaso e di una giovinezza ormai lontana diventava sempre più un ricordo mentre, aggrappato a un mondo in via d’estinzione, quasi ultimo dei gattopardi scialacquava i suoi beni nell’inettitudine a gestirli. E dinanzi al declino della sua fortuna, che si coniugava al tramonto di un’aristocrazia divenuta anacronistica, il barone La Lomia mostrava alterigia e insofferenza verso i ceti più bassi: “Iu sugnu lumia di ’ncapu l’arbulu, tu si lumia di ’nterra”, così si rivolse a un contadino con sprezzante spocchia nobiliare.
L’epilogo della sua esistenza fu triste e provata dalla povertà. Morì il 29 gennaio del 1978 nella casa di riposo Villa Serena di Gravina di Catania. L’indomani fu celebrato il suo funerale nella chiesa di San Domenico a Canicattì. Ma nessuna delle sue disposizioni – tranne quella di deporre nella tomba quaranta sacchetti di terra dei suoi feudi – fu rispettata. Non vi fu un carro funebre trainato da cavalli bianchi, nessuna banda intonò marce funebri, non si distribuirono gelati e dolciumi. A seguire il suo feretro si contarono poche anime. E i becchini internazionali, da lui invocati, disertarono l’appuntamento. Compreso quello del “cimitero della felicità” di Lisbona.
Antonino Cangemi – Scrittore