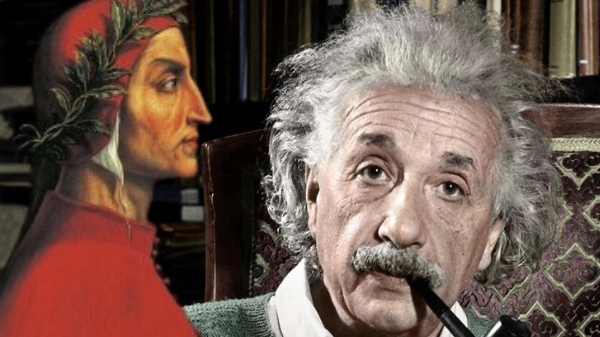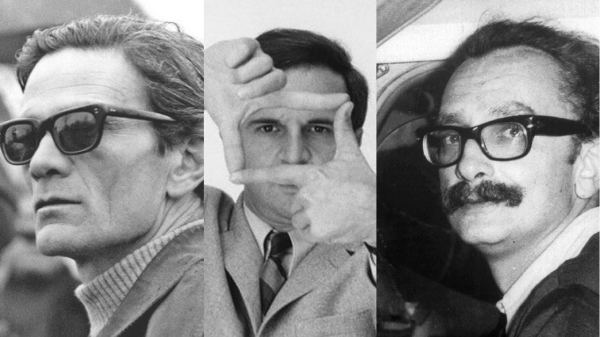Prosegue, con l’intervento della professoressa Beatrice Stasi, il dibattito sulle “due culture”, aperto su BeeMagazine dopo la pubblicazione dell’articolo del professor Mario Capasso, al quale sono seguiti contributi di altri esponenti della cultura umanistica e scientifica. Altri articoli seguiranno.
Dialogo di un fisico e di un metafisico: Leopardi tra le due culture (anzi tre)
“Fisico: Eureca, eureca.
Metafisico: Che è? che hai trovato?
Fisico: L’arte di vivere lungamente.
Metafisico: E cotesto libro che porti?
Fisico: Qui la dichiaro: e per questa invenzione, se gli altri vivranno lungo tempo, io vivrò per lo meno in eterno; voglio dire che ne acquisterò gloria immortale.
Metafisico: Fa una cosa a mio modo. Trova una cassettina di piombo, chiudivi cotesto libro, sotterrala, e prima di morire ricordati di lasciar detto il luogo, acciocché vi si possa andare, e cavare il libro, quando sarà trovata l’arte di vivere felicemente”.
Mi scuso se per intervenire nel vivace dibattito sul rapporto tra cultura umanistica e cultura scientifica, innescato su questa rivista da un articolo al tempo stesso dotto e appassionato di Mario Capasso (con altri successivi, autorevoli interventi), mi servo della maschera e delle parole di Giacomo Leopardi, che quasi due secoli fa questo dibattito aveva sceneggiato in una delle sue Operette morali, inventando un faccia a faccia tra uno scienziato (il fisico), che esulta per la scoperta del bersaglio numero uno di tutte le ricerche (scientifiche o negromantiche), e cioè un elisir di lunga vita, e un filosofo (il metafisico), che deprime l’entusiastica baldanza del suo interlocutore ribassando brutalmente il valore di scambio della scoperta, in nome di un conclamato scarsissimo appeal commerciale del suo oggetto, e cioè la vita in sé.
Mentre alchimia e scienza inseguono da sempre la possibilità di procurare all’uomo un rimedio contro la sua mortalità, alimentando favole e miti popolari (quando non addirittura proverbiali) fino al recente successo mondiale riscosso dall’accanita caccia alla pietra filosofale del Voldemort di Harry Potter, Leopardi rifiuta ogni esaltazione tributata al singolo scienziato (o alla ricerca scientifica tout court) per la sua capacità d’intervenire sul reale fino ad allontanare se non sconfiggere il suo spettro più temibile, quello della morte.
Non che il metafisico abbia una scoperta da contrapporre a quella atterrata – anzi, sotterrata – del fisico: nella prospettiva leopardiana l’arte di vivere felicemente, che sola conferirebbe valore alla scoperta di una pozione magica o di un ritrovato farmaceutico in grado di allungarci la vita, appare un obiettivo irraggiungibile tanto per la ricerca filosofica quanto per quella scientifica.
Ma anche, a ben vedere, per quella terza cultura rappresentata dall’area delle scienze sociali che cinquant’anni dopo il fortunato pamphlet sulle due culture del fisico Snow (dal quale il discorso di Capasso prende le mosse) è stata portata alla ribalta dallo psicologo Jerome Kagan in un libro apparso nel 2009 e tradotto in italiano nel 2013 (Le tre culture, Feltrinelli). Perché lo stesso argomento che ha permesso al metafisico delle Operette morali di liquidare come inutile qualsiasi elisir di lunga vita, permetterà qualche anno dopo al Leopardi epistolografo di stroncare per così dire sul nascere le ambizioni di quelle scienze sociali che all’epoca cominciavano a imporsi nell’orizzonte culturale e che quasi due secoli dopo si sarebbero viste riconoscere da Kagan tratti distintivi sufficienti a caratterizzarle in maniera autonoma tanto rispetto alla cultura scientifica quanto rispetto a quella umanistica.
Scrivendo all’amico Pietro Giordani da un contesto dinamico e à la page come la Firenze della prima metà dell’Ottocento, dove la bonomia del governo granducale consentiva agli intellettuali italiani di discutere e definire una progettualità politica e culturale stimolata dall’apertura di nuove prospettive epistemologiche, Leopardi non esitava a manifestare la sua inattualissima insoddisfazione:
“In fine mi comincia a stomacare il superbo disprezzo che qui si professa di ogni bello e di ogni letteratura: massimamente che non mi entra poi nel cervello che la sommità del sapere umano stia nel saper la politica e la statistica. Anzi, considerando filosoficamente l’inutilità quasi perfetta degli studi fatti dall’età di Solone in poi per ottenere la perfezione degli stati civili e la felicità dei popoli, mi viene un poco da ridere di questo furore di calcoli e di arzigogoli politici e legislativi; e umilmente domando se la felicità dei popoli si può dare senza la felicità degli individui. Così avviene che il dilettevole mi pare utile sopra tutti gli utili, e la letteratura utile più veramente e certamente di tutte queste discipline secchissime; le quali anche ottenendo i loro fini, gioverebbero pochissimo alla felicità vera degli uomini, che sono individui e non popoli”.
La lettera è datata 24 luglio 1828: potrebbe sembrare anacronistico cercarvi gli argomenti per parlare delle due culture di Snow o delle tre di Kagan, se la vis imaginativa dei poeti non ci avesse preparato a riconoscere nell’apparente passatismo di alcune posizioni un possibile scavalcamento profetico della dittatoriale urgenza dell’attualità.
Perché scegliendo ancora una volta come metro di paragone la felicità, il poeta che aveva messo in bocca al suo metafisico una condanna senz’appello dell’utilità pragmatica della scoperta (e che scoperta!) del fisico scienziato, contesta altrettanto pragmaticamente la funzionalità dei saperi che si andavano imponendo nell’orizzonte culturale italiano ed europeo (tutti sostanzialmente riconducibili all’area della terza cultura delimitata da Kagan). In questa prospettiva, quel “diletto” che appare il più leggero e forse irritante scopo della letteratura, recepito in maniera solo apparentemente supina dal classicista Leopardi fin da un suo appunto giovanile nello Zibaldone, finisce col rivendicare l’intimo impegno del suo esteriore disimpegno, presentandosi come la pur svagata materializzazione di una forma – la sola possibile – di felicità.
Lo spostamento del confronto su un piano sempre sdrucciolevole come quello della felicità insinua o forse dà per scontata una subordinazione di quello conoscitivo sul quale il confronto è solitamente impostato, ma anche un’apologia non tanto del sapere umanistico tout court, come strumento appunto di conoscenza, ma della letteratura come arte e invenzione (finzione) del bello.
Non che Leopardi sia il solo a proporre un approccio di questo genere: basterebbe scorrere il fitto (e tutt’altro che esaustivo) repertorio di citazioni che arricchisce uno dei rari best seller della saggistica di argomento letterario come L’utilità dell’inutile di Nuccio Ordine (2013) per rendersene conto.
Né bisogna dare per scontato che quest’apologia dell’inutile, di una non immediata applicabilità materiale delle invenzioni e dell’inventare umano, sia prerogativa esclusiva dei letterati: non per nulla in una recente riedizione (2020), il fortunato «manifesto» dello studioso di letteratura italiana è accompagnato dalla prima traduzione italiana del quasi omonimo saggio (The Usefulness of Useless Knowledge) di Abraham Flexner (1866-1959), in cui l’educatore americano, protagonista del processo di istituzionalizzazione degli studi medici negli Stati Uniti, rivendica il valore euristico di un approccio non utilitaristico anche per le scienze.
L’inutile? Il gratuito? Addirittura il bello? Certo, in tempi di crisi (e quali, ci si chiede, non lo sono) evocarlo rischia sempre di apparire una colpevole e “incredibile frivolezza da moribondi”, per dirla con Proust, e di ricordare il sapore, irrimediabilmente inacidito, delle brioches di mariantonettiana memoria.
Pure, basterebbe forse pensare all’importanza che nel moderno ripensamento di quegli stessi studi medici è (o, purtroppo, sarebbe più corretto dire dovrebbe essere) riconosciuta all’approccio proposto dalle cosiddette Medical Humanities per comprendere quale ruolo la letteratura e l’arte in genere possano recitare nel perseguimento di un benessere dell’ammalato che riconosca un suo irrinunciabile fondamento nella relazione umana tra medico e paziente, nella capacità di ascoltare (interpretare) del primo e di raccontare del secondo, e dunque non solo nei sofisticati strumenti di accertamento diagnostico che i fisici nostri contemporanei hanno saputo inventare, ma anche nella parola di metafisici o poeti, “la parola che cura, la parola che consola, la parola che salva”, come ricorda dalle sue pagine web il Centro Studi Medical Humanities dell’Università di Bologna, che non a caso ha la sua sede presso il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica.
In questa prospettiva, sarà forse fin troppo facile ricordare che fisici e metafisici, le due o le tre culture, i calcoli e gli arzigogoli politici e legislativi (ma forse anche letterari!) possono sempre, nonostante tutto, trovare una loro ideale convergenza, se non perdono di vista l’obiettivo di un bene comune. Il saggio di Flexner risale al 1939 e comincia evocando “a world steeped in irrational hatreds which threaten civilization itself” (“un mondo immerso in odî irrazionali, che minacciano la stessa civiltà”). Non serve forse altro, di questi tempi, per rendere, quella convergenza, più urgente che mai.
Beatrice Stasi – Professoressa associata di Letteratura italiana, Presidente Consiglio didattico di Lettere Unisalento