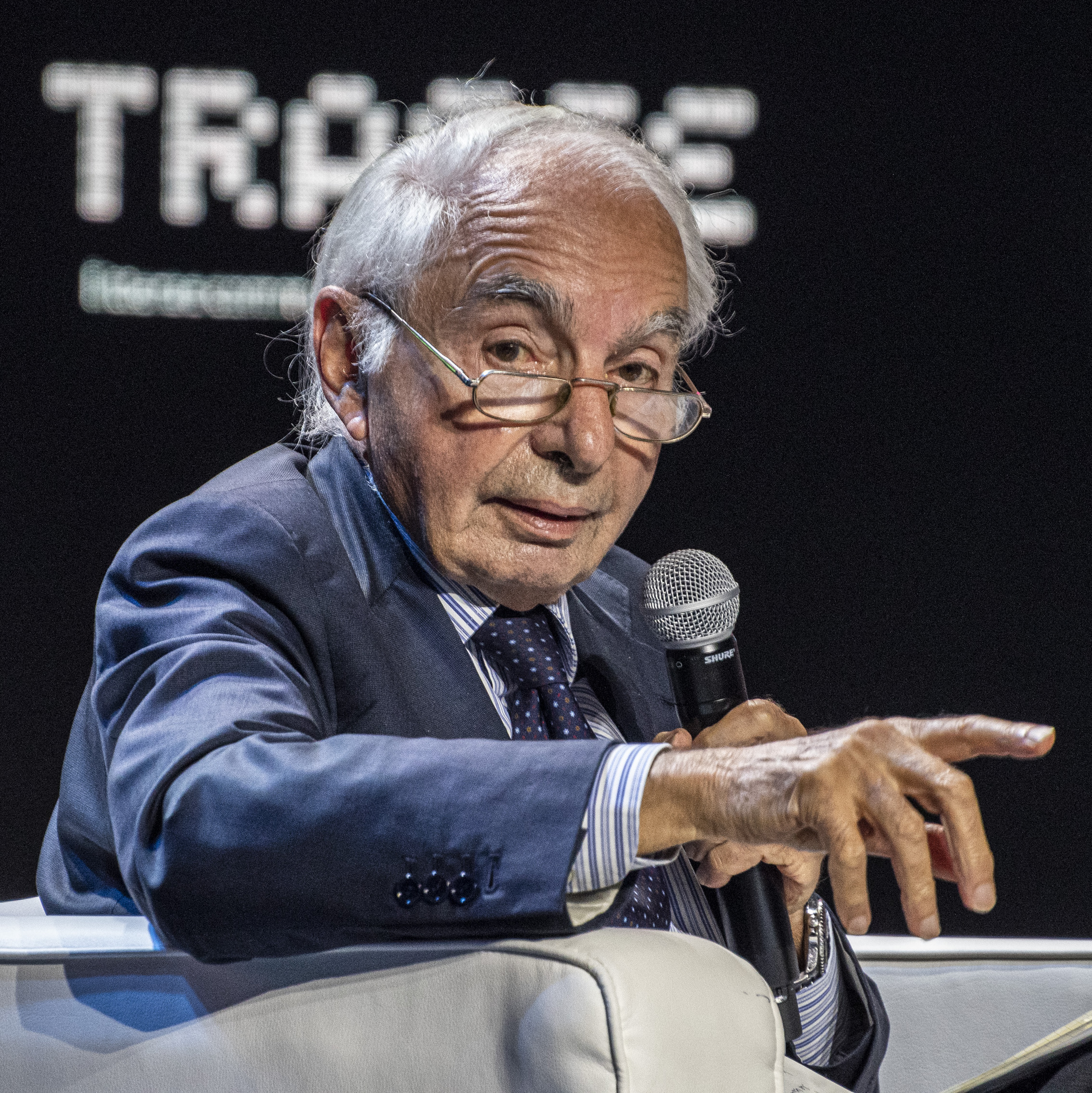Non c’è bisogno di scomodare le grandi anime di Ugo Foscolo, che dell’esilio fece quasi un genere letterario, o di Alphonse de Chateaubriand, che nelle Memorie d’Oltretomba ricordava con autoironica nostalgia la sua esperienza di emigré durante la rivoluzione francese, per comprendere che il destino di esule ha accompagnato la vita di molti letterati delle più diverse estrazioni.
“Dio è nato in esilio” è il titolo del romanzo con cui Vintila Horia, profugo romeno dopo l’avvento nel suo Paese della dittatura comunista, vinse nel 1960 il Prix Goncourt. Ed esuli politici furono dopo l’avvento del nazionalsocialismo personalità come i fratelli Mann, ma anche come il poeta espressionista Gottfried Benn, che però, laureato in medicina, per evitare di suonare il piffero alla propaganda nazista come letterato decise di rimanere in patria prestando però servizio come ufficiale medico, coniando lo slogan, espresso anche nel suo volume autobiografico Doppia vita, “l’esercito è la forma aristocratica dell’emigrazione”.
È stato però destino di uno dei più grandi romanzieri del secolo scorso sentirsi esule nell’arco di sessant’anni almeno tre volte e in tre forme diverse. È un amaro record di cui è giusto parlare, in occasione di una singolare ricorrenza: il cinquantenario dell’edizione italiana di Arcipelago Gulag, uscita il 25 maggio 1974 per i tipi di Mondadori, ponderosa e poderosa denuncia, sotto forma di inchiesta, dei campi di concentramento (e, di fatto, di sterminio) sovietici.
Il primo esilio Aleksandr Isaevič Solženicyn, nato nel 1918 in una cittadina russa alla pendici del Caucaso, morto a Mosca 90 anni dopo. l’aveva conosciuto quando nel 1945, giovane capitano di artiglieria promosso per meriti di guerra, fu arrestato per aver osato criticare Stalin nella lettera a un amico e condannato a otto anni di campo di lavoro e a tre di confino. “Esule in patria”, nel corso di quell’esperienza conobbe di tutto: l’abbandono della prima moglie, un tumore diagnosticatogli tardivamente, che lo portò in fin di vita, i primi approcci con la poesia, con versi che doveva impararsi a memoria, come i cantori dei tempi omerici, perché gli erano negate carta e penna; e infine il distacco dall’ideologia marxista, che in un primo tempo aveva condiviso, sia pur da posizioni critiche, e il ritorno alla fede ortodossa.
Lui che aveva ricevuto una formazione scientifica – dopo il rilascio insegnò per vivere matematica nelle scuole superiori – si dedicò alla letteratura e, tornato in libertà, pubblicò il testo che l’avrebbe posto al centro dell’attenzione nazionale e internazionale: Una giornata di Ivan Denìsovič. Il racconto, che descriveva la vita di un detenuto in un gulag, uscì nella rivista russa “Novyj Mir” nel 1962 e ottenne uno straordinario successo, sia per le sue qualità letterarie sia per il fascino suscitato dalle opere che toccano un argomento a lungo proibito.
A renderne possibile l’uscita era stato l’intervento del leader sovietico Nikita Chruščëv al Politburo. In piena campagna di destalinizzazione, quel racconto poteva costituire un argomento di potente impatto emotivo. E per un certo periodo Solženicyn, il cui racconto fu tradotto sia da Einaudi sia da Garzanti, fu visto in Italia come l’espressione di una sorta di socialismo cristiano, concetto in realtà lontano dalla sua evoluzione culturale. La sua influenza in Russia invece fu enorme. Circolava negli ambienti letterari la barzelletta secondo cui un ragazzo del ventunesimo secolo che domandava a un anziano. “Chi è Kruscev?” si sarebbe sentito rispondere: “Un politico dell’era di Solženitsyn”.
Nel 1964 proprio la caduta di Chruščëv, che pose fine alla fase di sia pur relativa democratizzazione dell’Urss (proprio sotto di lui era avvenuta la repressione della rivolta ungherese), provocò l’emarginazione di Solženitsyn, che ritornò esule in patria. L’Unione degli Scrittori vietò la pubblicazione del suo romanzo a sfondo autobiografico Padiglione cancro, ma l’uscita dell’opera in Occidente tramite i canali del samizadt ne provocò la completa emarginazione. Solženicyn, però, era ormai divenuto un caso internazionale e una presenza imbarazzante. Quando nel 1970 gli fu conferito il Premio Nobel per la letteratura la dirigenza comunista si trovò di fronte a un dilemma: tornare a perseguitarlo, facendone un caso internazionale che sarebbe stato deleterio per i partiti comunisti europei, o sbarazzarsene esiliandolo. Prevalse, dopo un tentativo fallito di avvelenamento, la scelta dell’espulsione, con la privazione della cittadinanza: un duro colpo per uno scrittore visceralmente legato non all’Urss ma alla Santa Madre Russia.
Era il 1974, l’anno della traduzione italiana di Arcipelago Gulag, un anno in cui l’egemonia marxista sulla nostra cultura raggiungeva forse il culmine. Il volume usciva con i tipi della Mondadori, ma senza il battage pubblicitario che l’opera, già edita in Francia, avrebbe meritato. E subito arrivarono non solo le prevedibili censure dei dirigenti comunisti, come quella di Giorgio Napolitano, ma anche di molti intellettuali più o meno organici alla linea del Pci. Carlo Cassola sulle colonne del “Mondo” stroncò Solženicyn come “un retore declamatorio che non vale niente come scrittore”, Dedalus, pseudonimo di Umberto Eco, sul “Manifesto” lo liquidò come “un Dostoevskij da strapazzo” (ma già qualche anno prima Pasternak era stato classificato un “Tolstoj di serie C”). Alberto Moravia, con diverse sfumature, cercò di attribuire le asprezze del sistema concentrazionario sovietico non al comunismo, ma al retaggio autocratico della Russia zarista. Piero Citati ebbe il merito di pubblicare la prima recensione di un certo spessore, sul “Corriere della Sera”, anche se scorse nell’opera più un memoriale storico-biografico che un capolavoro stilistico.
Più coraggioso fu il sostegno all’opera recato da Enzo Bettiza, sulle colonne del “Giornale Nuovo” di Montanelli, che iniziò le pubblicazioni un mese dopo l’uscita di Arcipelago Gulag, e da Eugenio Montale, che tentò di portare in Italia lo scrittore per un ciclo d’incontri. Come succede spesso in questi casi, contro Solženicyn cominciarono a circolare le solite calunnie, come quelle sui “lauti diritti d’autore” accumulati sui conti svizzeri (e dove avrebbe dovuto accumularli, visto che era stato trasformato in un apolide?)
Erano anni “formidabili”, come li avrebbe definiti Mario Capanna, ma, per molti aspetti, tali nell’accezione latina di “terribili”. In ampi settori non solo della cultura, ma dell’economia e nello stesso mondo ecclesiastico era diffusa la sensazione che l’Unione Sovietica stesse vincendo la guerra fredda. Parevano confermarlo la congiuntura internazionale, con l’imminente impeachment di Nixon, la fallita “vietnamizzazione” del conflitto nel Sud-Est Asiatico, la “rivoluzione dei garofani rossi” in Portogallo, con relativa deriva castrista, la diffusione della teologia della liberazione che destabilizzava l’America Latina,.
Sotto questo profilo, l’Italia del compromesso storico anche sotto il profilo culturale era molto diversa dai paesi anglosassoni dalla Francia, in cui Arcipelago Gulag era già uscito e avrebbe qualche anno dopo contribuito ad alimentare la nouvelle vague dei “nuovi filosofi”, con la denuncia – per citare il titolo di un celebre saggio di Bernard-Henri Lévy – della “barbarie dal volto umano”. Negli Stati Uniti, specie sotto la presidenza di Jimmy Carter, statista bistrattato dalla storia, la questione dei diritti umani fu posta coraggiosamente all’ordine del giorno, prima ancora delle denunce di Ronald Reagan contro “l’impero del Male” sovietico. In questa realtà un volume come Arcipelago Gulag finì per svolgere un ruolo centrale, anche se è forse esagerato sostenere che abbia davvero cambiato la storia del mondo.
Così Solženitsyn con le sue denunce fu eletto “braccio morale dell’Occidente” e accolto con tutti gli onori negli Stati Uniti d’America, all’università di Stanford, e insignito della laurea honoris causa ad Harvard. Proprio in quell’occasione, però, si palesò il grande equivoco di chi aveva visto in lui un acritico difensore della way of life statunitense. Nel corso della cerimonia, che si svolse l’8 giugno 1978, lo scrittore pronunciò un discorso nel quale criticava proprio il “senso di superiorità illusorio” dell’Occidente. “Una persistente cecità – scrisse – induce a credere che tutte le vaste zone in cui è diviso il nostro pianeta debbano seguire uno sviluppo che le porterà a sistemi analoghi a quelli occidentali attuali, i più avanzati da un punto di vista teorico, i più attraenti da un punto di vista pratico; che tutti gli altri mondi siano solo temporaneamente trattenuti – vuoi da cattivi governanti o da sconvolgimenti interni, o dalla barbarie e l’incomprensione – dal lanciarsi sulla via della democrazia pluripartitica di tipo occidentale e dall’adottare il modo di vita dell’Occidente.”
Riaccostatosi alla fede ortodossa, Solženitsyn non amava la cultura pop, la musica rock, condannava la disgregazione morale della società statunitense e accusava l’Europa di avere “la malattia del vuoto”. A chi gli faceva notare che proprio nella “santa” Russia si era insediata una dittatura comunista, replicava che il marxismo era un prodotto della civiltà occidentale e, come avrebbe ricordato nel 1993 durante un memorabile viaggio in Vandea in compagnia di Philippe De Villiers, aristocratico ed ex ministro giscardiano, indicò nei massacri giacobini le premesse per gli orrori staliniani.
Maturavano le condizioni necessarie per sentirsi nuovamente esule: prima negli Stati Uniti, che l’avevano accolto ma di cui non condivideva gli stili di vita, poi nella Russia di Eltsin, di cui condannava le politiche anarcoliberiste, il turbo-capitalismo, la svendita del patrimonio pubblico a oligarchi in combutta con le multinazionali straniere, persino l’imbastardimento del lessico (“Perdiamo le nostre parole russe, imitiamo come scimmie quelle altrui: voucher, holding, farmer. È una malattia del nostro spirito più che della nostra lingua”).
Beninteso, Solženicyn non provava nessuna nostalgia per il passato sovietico. “Si può rimpiangere – diceva – un regime che scriveva dio con la minuscola e Kgb maiuscolo?” Ma la democrazia post-sovietica l’aveva profondamente deluso. Anche per questo motivo, l’interesse per la sua opera in Occidente andò scemando. Se Arcipelago Gulag era uscito con la Mondadori, una delle sue ultime opere – Due secoli insieme, dedicata al rapporto fra russi ed ebrei – fu pubblicata da Controcorrente, una piccola casa editrice specializzata nel revisionismo storico, soprattutto in chiave neoborbonica. E subì ingiustificate accuse di antisemitismo.
Nella Russia di Putin Solženitsyn smise di sentirsi un “esule interno”. Arcipelago Gulag divenne una lettura obbligatoria nelle scuole superiori e l’ex tenente colonnello del Kgb manifestò la sua ammirazione nei confronti dell’ex deportato. Solženitsyn, che nel 1999 aveva condannato l’intervento della Nato a sostegno degli indipendentisti kosovari contro la Serbia ortodossa, accusò la Nato stessa di voler accerchiare la Russia, un tema che avrebbe costituito un leit motiv della propaganda putiniana, e scavalcò addirittura a destra il presidente quando si dichiarò favorevole alla pena di morte per i terroristi. Quando morì, il 3 agosto 2008, sia Putin sia Gorbaciov, le due anime della Russia post-sovietica, gli resero omaggio, sia pure da posizioni divergenti. Ma Putin era allora uno statista omaggiato e rispettato, corteggiato da politici di tutti gli schieramenti, anche perché la Russia era pur sempre “una pompa di benzina con annesso arsenale atomico”.
Chi scrive non ha mai nutrito molta simpatia per il gioco, un po’ snob un po’ kitsch, di figurarsi come si sarebbe schierato un grande personaggio del passato dinanzi alle problematiche del presente. Meglio lasciare al lettore immaginare se il disgusto dinanzi all’aggressione all’Ucraina, alla repressione della dissidenza interna, ai rigurgiti neostalinisti nella Russia di Putin sarebbero prevalsi sulla gratitudine per l’uomo che non l’aveva fatto più sentire un “esule interno”.
Una realtà, comunque, rimane inalterata, a mezzo secolo di distanza da quella prima sofferta edizione italiana di Arcipelago Gulag: fu Solženicyn, sia pure da posizioni diverse da quelle di un Sacharov, a sferrare il primo colpo contro il regime comunista. E non è del tutto da escludere che fra mezzo secolo un nonno, interrogato su chi era Putin, possa rispondere al nipotino: “Un politico dell’era Solženicyn, che ne fraintese il messaggio”.
Enrico Nistri-Saggista