Giustamente vari osservatori denunciano quell’immersione della politica in un indefinito “presentismo” (che amo definire “oggicrazia”) del discorso pubblico e del confronto politico italiano. A ben vedere alla “oggicrazia” si aggiunge, però, quella che si può definire “iericrazia”. Spesso, infatti, il confronto politico matura andando a rovistare nelle vicende e nei residui del passato.
Magari per disporre di una “clava” contro gli avversari politici del momento. Vuoi che si tratti di aspetti di riletture o revisionismi di vicende storiche, vuoi che si tratti di agitare la clava ideologica un po’ come è avvenuto in riferimento alla questione del Manifesto di Ventotene, così ben trattata da queste colonne nei giorni scorsi da Pino Pisicchio
Si tratta di un fenomeno o di una strana sindrome che ha colpito e colpisce sia le forze di maggioranza sia di opposizione. Vuoi che si tratti del Caso Moro, o della strage di Bologna, o di quella di Ustica. Vuoi che si tratti di vicende di un passato più recente come in riferimento alla questione della pandemia o del Covid. Magari si agitano nello shaker del confronto politico questi ingredienti, spesso con riletture di comodo, e spesso si costituiscono anche commissioni parlamentari di inchiesta.
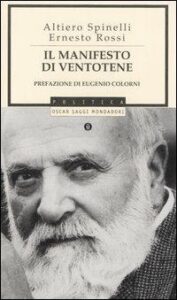
La politica ossessionata dal passato
È come se la macchina della democrazia italiana fosse guidata guardando esclusivamente dallo specchietto retrovisore. Mentre ben raramente si cerca di illuminare il cammino verso il futuro tramite l’accensione di fari appropriati. Ciò lo dimostra anche in questa fase il fatto che mentre noi abbiamo passato giorni e giorni, passaggi politici e parlamentari cruciali per rinfacciarci reciprocamente la rilettura o una qualche forma di revisionismo sul Manifesto di Ventotene, in Germania le principali forze politiche democratiche si sono impegnate fortemente, invece, a varare una storica modifica della Costituzione che elimina il vincolo del freno al debito pubblico, favorendo così un bazooka fatto di investimenti nel sistema degli armamenti e delle infrastrutture che arriverà fino a 500 miliardi.
Lì dunque ci si sta confrontando con seri obiettivi operativi su come reagire rispetto al pericoloso mix tra la crisi economica, gli effetti del trumpismo e le nuove sfide dell’Europa. Un fenomeno per certi versi analogo avviene in Spagna, dove sia i socialisti sia i popolari, convergono nel rispondere unitamente alle sfide della difesa europea e per il rilancio economico del Paese.
La politica della “iericrazia” è una declinazione del populismo
Da noi invece si rimescola con mestoli bucati sul passato. Il fatto è che la “iericrazia” e una visione della democrazia centrata sullo specchietto retrovisore sono figli di quel metodo più o meno esplicitamente populistico che caratterizza il modo di fare politica in Italia. Ed è proprio per un metodo di questo genere che, invece di affrontare i problemi, cercare soluzioni, confrontarsi su politiche pubbliche adeguate alle gravi sfide di questi tempi, si rimescolano – pescando dalla botte della storia – questioni ideologiche spesso agitate come clave in modo strumentale.
Forse i cittadini questo lo hanno capito e proprio da fattori di questo genere deriva il fatto che nel frattempo, senza che nessuna forza politica se ne preoccupi, guarda caso, l’effettivo corpo elettorale si è dimezzato. Proprio perché i cittadini vedono i partiti schermagliare tra di loro in questo modo, rinchiusi nell’agone politico, invece di affrontare i problemi della gente e del Paese. Di qui lo sciopero di almeno il 50% di essi dalle urne.
Luigi Tivelli – Già consigliere parlamentare. Saggista. Presidente dell’Academy Spadolini






