Se chiudere un padiglione alla Biennale di Venezia è un gesto politico anche l’arte allora è (sempre) politica. Ci vorrebbe il punto di domanda dopo questa frase. Ma se non lo si mette si comincia a respirare proprio l’aria che Adriano Pedrosa, il curatore di origini brasiliane della Biennale 60a edizione, aveva creato con il suo tema annunciato da tempo, quello di “Stranieri ovunque”.
La chiusura del padiglione di Israele – volontà del curatore di quel paese e delle due artiste che avevano curato l’esposizione – sarà provvisoria, come dice il cartello visibile dal primo giorno della pre-apertura della mostra: “Fino a quando, cioè, non cesserà la guerra e non saranno liberati gli ostaggi”.


A ben pensarci, la liaision “arte/politica/padiglione chiuso” è apparsa più volte, e con un certo fragore, a Venezia. Senza aprire gli archivi, andando a memoria, trent’anni fa circa l’algida Svizzera che non aveva mai scalato classifiche da exploit memorabili aveva fatto tutto per benino come al solito lasciando però chiuso l’ingresso. Meglio: si doveva entrare (a proprio rischio e pericolo, ricordava un cartello) salendo una insicura scala appoggiata ad un muro. Un gesto simile a quello che facevano i clandestini che varcavano una soglia, un confine, una linea di un altro territorio, diverso, straniero.
Una decina di anni dopo la Spagna si è spinta più in là. Sulla porta d’ingresso del reale padiglione, (primo a sinistra nell’entrata dei Giardini) meno grigio ma altrettanto austero di quello della Svizzera un cartello indicava che l’ingresso da utilizzare sarebbe stato quello laterale sul lato ovest pochissimo conosciuto e forse mai utilizzato dal pubblico. Una guardia giurata, italiana, chiedeva il passaporto per poter accedere. “Senza passaporto non si può entrare, questo è territorio spagnolo, mi dispiace”.
Non era uno scherzo. I pochi spagnoli col passaporto una volta entrati non avrebbero trovato alcun allestimento, non un quadro, non un’installazione, nemmeno una foto con dicitura.
Il gesto artistico (politico) era quello di far notare la differenza, segnalare l’estraneità, impedire che i confini fossero oltrepassati. Anche se la delusione degli spagnoli di fronte al nulla del proprio padiglione sarebbe stata motore per molte riflessioni.
E in fondo in fondo un altro padiglione chiuso – quello della Grecia, nel 1948, allora per colpa della guerra civile in quel paese – ha aperto le strade alla fama italiana di Peggy Guggenheim che sta per diventare venezianissima e che utilizzò quegli spazi per far vedere al nostro paese ancora alle prese con la ricostruzione l’arte moderna e contemporanea che lei stava collezionando. Collezione, quella di Peggy, che ancora adesso rimane un’icona internazionale.

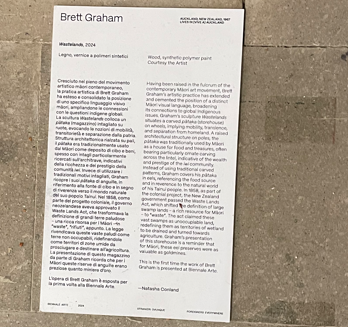
Che effetto fa vedere una mostra d’arte dichiaratamente in mano ad altri mondi, dove l’Occidente non passa in secondo piano ma è obbligato – anche con divertimento qualche volta, come nel padiglione francese – a riflettere sull’estraneità, quella situazione per cui qui i veneziani usano la parola “foresto”? Foresto è tutto quello che viene da fuori e resta altro/diverso/con caratteristiche proprie però che possono anche essere apprezzate; dei foresti Venezia ha così tanto trattato e così tanto si è interessata che nella sua millenaria storia quasi non esistono leggi per regolarne ingressi, accessi e permanenze. Pochissime norme per la tutela di un equilibro che con la modernità si è ovunque frantumato.
La Biennale di “Foreigners everywere” vuole denunciare mostrando in tutta la sua crudità l’arte “straniera”: nei sessi, nella nazionalità, nelle scelte culturali, nella filosofia ma non nelle forme che tornano – dopo decenni stracolmi di videoinstallazioni e filmati da fare concorrenza alla Biennale cinema – a quelle comprensibilmente vicine alla quotidianità di ognuno dove un quadro è un quadro e un’installazione molto differente da una selva di tubi innocenti/cantiere edile. (oddio c’è anche quello ma quando lo si trova si capisce subito dove stanno certe differenze e dove certi concetti, “musicali” magari, non impressionano ormai più.

Perché la prima impressione di questa “Edizione Sessanta” è di uno scoppio diffuso di allegria, di fantasia lasciata correre, di vorticoso entusiasmo. Che viene sì dal Sud delle Americhe, dai tanti Oriente, ma anche dalla compatta vicinanza che la Biennale permette. Senza creare ottundimenti, ma concentrando, distillando le emozioni di grandi regioni del pianeta per toppo tempo rimaste senza voce.

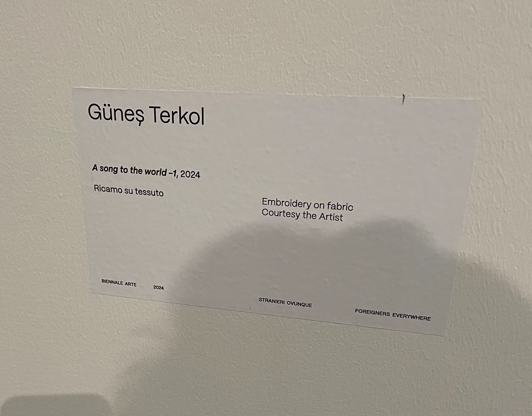
Aveva detto Pedrosa qualche tempo fa presentando la mostra: “Il termine italiano straniero, il portoghese estrangeiro, il francese étranger e lo spagnolo extranjero sono tutti collegati sul piano etimologico rispettivamente a strano, estranho, étrange ed extraño, ovvero all’idea di estraneo. Viene in mente il concetto freudiano di Unheimliche, Il perturbante nell’edizione italiana, che in portoghese è stato tradotto con O estranho, a indicare lo strano che, nel profondo, è anche familiare. Secondo l’American Heritage e l’Oxford English Dictionary, il primo significato della parola “queer” è proprio “strange” (“strano”), pertanto la Mostra si sviluppa e si concentra sulla produzione di altri soggetti collegati: l’artista queer, che si muove all’interno di diverse sessualità e generi ed è spesso perseguitato o messo al bando; l’artista outsider, che si trova ai margini del mondo dell’arte, proprio come l’autodidatta, l’artista folk o artista popular; l’artista indigeno, spesso trattato come straniero nella propria terra”. Pedrosa stesso, ormai lo si sa, si è detto “queer”. Ma non si pensi un istante che la forma dell’interesse sia solo perché non occorre distinguere, soffermarsi, dividersi sul sesso.

L’arte è politica? (stavolta con il punto di domanda). E allora guardi bene anche al passato, per aiutare a rimodellare un futuro che si annuncia difficile ovunque.
Per questo il percorso nel nucleo storico – elemento forte della Biennale, voluto dal curatore brasiliano, il primo proveniente dall’America latina ad una Biennale – che raccoglie opere del XX secolo dell’America Latina, Africa Medio Oriente e Asia sono anche uno specchio dove il modello occidentale contemporaneo deve confrontarsi con le prospettive di tutto il mondo. Dove gli assi stanno mutando e gli equilibri convergono verso altri orizzonti.
Ancora più interessante allora soffermarsi nella sezione “Italiani Ovunque” dedicata alla diaspora artistica italiana nel mondo nel XX secolo. “Artisti italiani – spiega sempre Pedrosa – che hanno viaggiato e si sono trasferiti all’estero, costruendo la propria carriera in Africa, Asia, America Latina, nonché nel resto d’Europa e negli Stati Uniti. Italiani all’estero, spesso immersi nelle culture locali, che hanno svolto a volte un ruolo significativo nello sviluppo delle narrazioni del Modernismo al di fuori della propria terra d’origine.

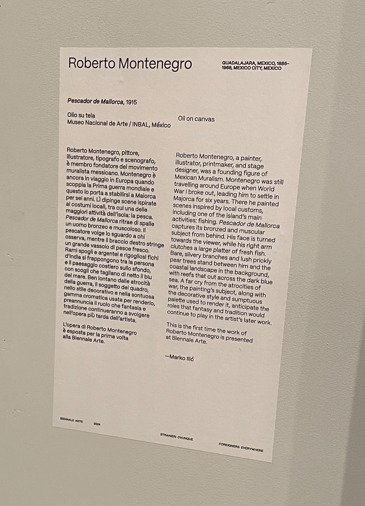
Ci fermiamo qui per il momento. Ci potremmo dare appuntamento fra qualche giorno, dopo aver esplorato anche le diciture più nascoste dei padiglioni e cercare di capire che fine faranno le mele marce che danno elettricità ai sensori del padiglione giapponese.
L’esposizione d’arte più importante al mondo ha un terribile difetto, sappiatelo tutti: è troppo grande per qualunque essere umano, e dovrebbe essere vista in tre giorni almeno. Ma forse nemmeno cinque bastano per farsi un’idea. Vista non equivale a capirla. Anche se, per fortuna, dentro questo Gigante dell’Arte – 300 artisti, 100 paesi, 30 eventi collaterali ufficiali, 96 eventi o esibizioni autonome, 18 fondazioni 14 spazi d’arte, 8 musei, 19 gallerie: tutti in contemporanea, sempre; si chiude il 24 novembre – dove tutti hanno storie da dire da far vedere “capire” diventa una delle sfide più interessanti della contemporaneità. Si può anche perdere questa sfida ma il senso della ricerca della libertà che sa offrire l’arte è così inebriante che parlare di politica, in questi posti, potrebbe diventare perfino consolante.
Adriano Favaro – Giornalista







