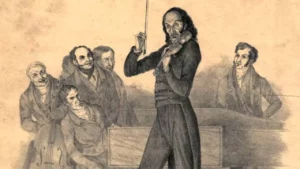C’era una volta un professore che corteggiava le sue studentesse. Non proprio il massimo del bon ton accademico, direte voi. E invece no: secondo il Tribunale di Catania, trattasi non di molestia sessuale, bensì di “*corteggiamento ossessivo*”. Come dire: la rosa offerta con insistenza non punge penalmente. Al massimo infastidisce.
Una sottigliezza degna di scuola logico-formale: il confine tra molestia e galanteria reiterata, pare, sarebbe tracciato non dal codice penale, ma dall’educazione sentimentale. Il problema? Che il corteggiamento in questione includeva, secondo i fatti contestati, anche “improvvisi palpamenti del seno” – circostanza che per la Suprema Corte configura senza troppe esitazioni una violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., checché ne pensi l’amor cortese di provincia.
Già nel 2020, le Sezioni Unite (sentenza n. 22163) avevano chiarito che l’abuso di autorità può sussistere anche in forme di fatto e di natura relazionale, senza bisogno di un ruolo formalmente pubblico. Tradotto in lessico ordinario: se sei un professore e l’altra è una studentessa, la tua aura cattedratica può bastare a rendere viziato il consenso. Il principio è chiaro: il potere, anche quando non indossa la toga o il distintivo, pesa.
Ma a Catania, si sa, la logica giuridica ha i suoi profumi locali. E infatti il giudizio di inattendibilità delle ragazze si fonda su un dettaglio degno di miglior teatro pirandelliano: una delle presunte vittime ha scelto proprio il professore molesto come relatore di tesi. Che dire? O era masochismo accademico, o un calcolo opportunistico. Oppure – ipotesi più semplice – il rapporto docente-discente è una gabbia dorata, da cui spesso non si fugge, per paura, convenienza o assuefazione.
Corteggiamento: Senza dissenso esplicito niente reato (sic!)
In ogni caso, il Tribunale ha archiviato il tutto con una teoria ardita: senza dissenso esplicito, non c’è reato. Peccato che la Cassazione, nel 2023 (sent. n. 23466), abbia detto il contrario: basta l’assenza di consenso, il dissenso non deve essere urlato in maiuscolo. La logica è opposta: in materia di libertà sessuale, il consenso va provato, non presunto. E quando l’equilibrio di potere è distorto, ogni “sì” rischia di essere una finzione giuridica.
Non solo: la stessa Cassazione ha ammonito i giudici contro “la supina accettazione di stereotipi culturali ampiamente superati” – quelli che, con gesto cavalleresco ma anacronistico, continuano a credere che la donna debba difendersi con un “no” gridato e inequivocabile, pena il silenzio assenso. A Catania, pare, tali stereotipi godano ancora di ottima salute processuale.
Il processo? È un dramma in tre atti
In sintesi: mentre a Roma la giurisprudenza costruisce con certosina pazienza una dottrina della tutela effettiva della libertà sessuale – dove il potere è elemento di coercizione anche implicita – in Sicilia sembra nascere un nuovo ramo del diritto: il corteggiamento giuridicamente corretto, dove anche le mani troppo curiose possono passare per gesti affettuosi mal interpretati.
Chi ha ragione? In teoria, la Corte di Cassazione, che chiude il gioco. Ma nel teatrino giudiziario italiano, anche le sentenze sono drammi in tre atti, e talvolta la logica si perde dietro il sipario della prassi.
E vissero tutti confusi e contenti. O almeno fino al prossimo appello.